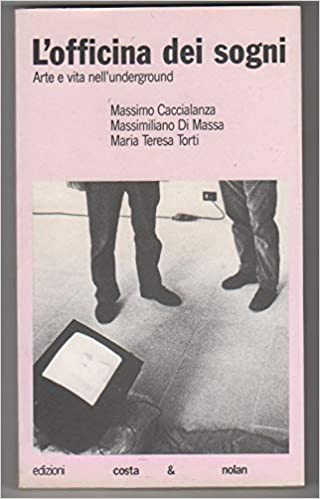
Era l’inizio degli anni ’90 quando quattro amici e colleghi si sono messi intorno ad un tavolo e hanno cominciato a chiedersi “ma cosa sta succedendo intorno a noi”? Perché c”è un sacco di gente che passa il proprio tempo libero coinvolta in progetti creativi”? Quali sono le matrici soggettive e oggettive di tutto questo fermento e bisogno di esprimersi? I quattro amici erano poi chi ricercatori professionisti del sociale altri operatori del settore culturale e del divertimento con una grossa curiosità e una certa propensione all’indagine sociale. Questo mix d’interessi passioni e competenze è confluito in un progetto, un percorso di ricerca che ha coinvolto sia i ricercatori sia l’oggetto/soggetto dell’indagine, e che ha portato all’attivazione di una serie di processi sociali che tenteremo di dare conto alla fine di quest’articolo.
L’oggetto del nostro ricercare era la comprensione delle culture underground, sottoculture, controculture. Nell’accezione di Dick Hebdige “le sottoculture rappresentano un ‘rumore’ (come opposto di suono): interferiscono nella normale successione che porta dagli eventi e dai fenomeni reali alla loro rappresentazione nei media, (…) ad un effettivo disordine semantico”. Culture operanti in un ambiente che è quello della Società di Massa, una società caratterizzata da una situazione in cui l’informazione ha preso il testimone e produce gli effetti culturali e psicologici più significativi, sostituendosi alle opere di fantasia nel processo di socializzazione democratica individualista. Effetti che hanno contribuito ad uno sviluppo delle intelligenze e delle coscienze individuali sino a raggiungere, al livello attuale, una posizione predominante rispetto a qualsiasi altro tipo d’atteggiamento conoscitivo.
I gruppi di persone che si incontrano in questo ambiente ricercano codici attraverso cui filtrare e rappresentare la realtà allo scopo di sfuggire all’oppressione, per uscire dalle paure e dall’isolamento indotto dall’alluvione informazionale. I linguaggi e i codici di riferimento usati a questo scopo sono definibili ‘contemporanei’ nel senso che incanalano, da una parte, le esperienze individuali e quotidiane e, dall’altra, il complesso delle comunicazioni. Questo fino all’elaborazione di metalinguaggi, di neolingue, prodotti dall’interrelazione tra realtà e immaginario, tesi a soddisfare le contraddizioni che si realizzano nei percorsi creativi tra l’esigenza della costruzione di un processo di disidentità e la necessità di ricostruzione di un ambito simbolico nel quale riconoscersi, sospeso tra utopia e realizzabilità.
Utopie che corrispondono a frammenti di realtà, ad ambiti simbolici nel quale reinventare la realtà. Utopie che si materializzano nella creazione di simulacri, di un sistema retorico nel quale si possono reinvestire quelle che sono le energie negate al sistema ufficiale. I linguaggi – ribadiamo – si confondono molte volte nel tentativo di costruire nuove ‘filosofie’ che si presentano forse più autostrutturate e non ancorate a sistemi di pensiero rigido, eterodirette, meno catalogabili in schemi di tipo dogmatico o ideologico; tali filosofie sono forse, in quella fase, sempre meno conflittuali ma, non per questo, meno antagoniste.
Una città come Genova – inserita, secondo un ragionamento puramente teorico nell’area ‘ricca’ del paese – diventa il luogo di concentrazione e di rielaborazione di una miriade di messaggi che corrono lungo le maglie di una rete di relazioni, formata da altre reti; il concetto di network si afferma in tutta la sua pienezza. I luoghi istituzionali (oramai non più molto) della veicolazione e della produzione dei beni immateriali, la fabbrica del senso si sfalda insieme allo sgretolamento degli apparati tradizionali del consenso e dell’opposizione.
© 2025 Edizioni del Frisco
Tema di Anders Norén — Su ↑