In un mondo sempre più digitale e interconnesso, il processo di archiviazione del materiale visivo è cambiato radicalmente.
Desideroso di approfondire questo aspetto, ho deciso di analizzare come viene portata avanti questa pratica nel panorama creativo contemporaneo.
Nel suo periodo di massimo splendore, sembrava che Facebook fosse concepito quasi esclusivamente come uno spazio disponibile su cui caricare corposi album di decine e decine di fotografie, spesso simili o addirittura uguali fra loro, di serate fuori con gli amici e situazioni del genere. Oggi, con una dinamica che quindi avvertiamo come familiare, ritroviamo sui vari profili Instagram quelle che possiamo definire “pagine-archivio” dedicate ad argomenti di nicchia che emergono dal mondo dall’arte popolare – definita a suo tempo grassroots da Henry Jenkins – come i tutorial di trucco, i collage, la tipografia cinetica, e chissà cos’altro. Per alcuni anni gli strumenti come le piattaforme di condivisione delle immagini (da Pinterest a Instagram), sono state viste come lampanti indizi della deriva estetizzante delle nostre società, definite non a caso come “ossessionate dall’immagine”.
Credo che oggi sia pacifico sostenere che tali atti siano invece la testimonianza della tendenza sempre più diffusa – mi verrebbe da dire necessaria – di archiviare e, nel farlo con sempre maggiore frequenza, competenza e tecnologie, di indagare come questi nuovi modi dell’archiviazione vanno a incontrarsi con le differenti pratiche artistiche.
Si tratta di un campo già in parte preso ad oggetto di studi da autori che negli ultimi due decenni, non a caso sono stati oggetto di una più o meno generale riscoperta; mi riferisco non solo all’immancabile Walter Benjamin, ma soprattutto ad Aby Warburg e Georges Didi-Huberman. Sullo stesso percorso speculativo si sono mossi anche altri fra i quali l’Umberto Eco della Vertigine della lista (Bompiani, 2009) e, per certi versi, anche il Nicolas Bourriaud di testi quali Postproduction: come l’arte riprogramma il mondo (Postmedia Books; 2004) e Estetica relazionale (Postmedia Books; 2010). In questo contesto di studi però, il testo che ritengo centrale per il tema che stiamo trattando è quello di Cristina Baldacci con il suo Archivi impossibili (Johan & Levi; 2016), volume che non circumnaviga il tema del rapporto fra arte e archivio ma, anzi, lo centra attraverso una serie di ottimi esempi sia di autori che di testi, dando così il via ad un filone di studi che a mio avviso sarà sempre più centrale in futuro.

Con l’ascesa di Internet, la capacità di preservare i contenuti visivi e le modalità con cui farlo sono infatti oltremodo proliferate. Il potenziale di archiviazione e salvataggio, la disponibilità di programmi, piattaforme di social media e siti Web ha cambiato il modo in cui pensiamo la conservazione digitale. Sembra oramai lontana la percezione austera e grigia che per secoli ha accompagnato il mondo degli archivi come ambienti chiusi, inaccessibili, esclusivamente appannaggio di istituzioni accademiche e musei. Oggi – al contrario – tutti noi possiamo in un certo qual modo definirci archivisti. Archiviamo infatti continuamente, in forme e modalità che continuamente si reinventano, ponendo al centro del nostro organizzare temi quali la condivisione e la collaborazione, mai prima di oggi davvero centrali nell’attività archivistica.
Oggi l’archivio può essere un modo per rendere omaggio a stili creativi del passato, tracciare collegamenti tra l’eredità di tendenze e tecniche o un mezzo per creare contesti in cui la conoscenza su determinati argomenti si espande attraverso relazioni.
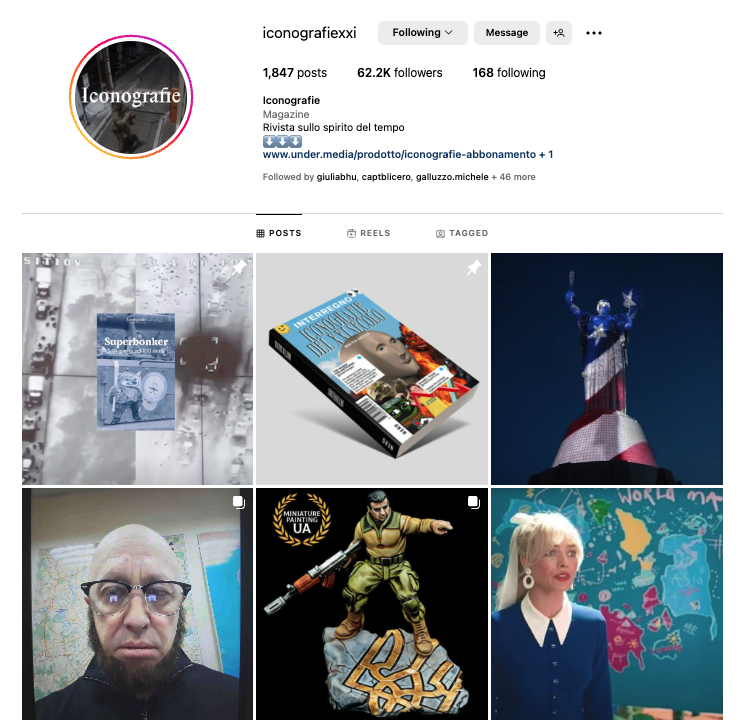
iconografiexxi, per esempio, è un profilo Instagram creato e curato da Mattia Salvia, autore del fortunato libro Interregno. Iconografie del XXI secolo (Nero Edizioni, 2022). La pagina è una miniera d’oro per gli amanti dell’estetica digitale più sofisticata e per certi versi cursed, un luogo in cui vengono condivise regolarmente fotografie e scansioni di attualità soprattutto politica.
Un altro archivio, sempre italiano, è quello costruita da Cronache Ribelli, progetto nato nel giugno del 2016 dal collettivo Cannibali e Re che, come recita la loro bio: “si pone l’obiettivo di creare uno spazio di racconto storico alternativo a quelli classici poiché mette al centro della sua narrazione le vicende delle classi popolari, delle minoranze e delle soggettività oppresse”.
Gli esempi potrebbero davvero essere infiniti, si va da chi archivia oggetti di ogni sorta (pensiamo ad 99objects), a chi tenta di recuperare tradizioni e movimenti del passato (Compulsive Archive), da chi riporta a galla i diari (Piccolo Museo del Diario) o i quaderni delle scuole elementari (Quadernini), chi colleziona libri brutti o libri belli, chi ricerca e cataloga foto di Silvio Berlusconi. Io ho solo ricordato esempi italiani, quindi capite bene che ce n’è davvero per tutti i gusti.
Un aspetto però comune a molti archivi contemporanei grassroots è la nostalgia come zeitgeist culturale – e come questa si manifesti come un’arma a doppio taglio. Se osserviamo per esempio alla raffica di rebranding più o meno recenti come Burger King, Pepsi e molte altre grandi aziende, notiamo che tutte tendono ad un ritorno ai loro vecchi loghi – come se quello che si ricercasse fosse quella confort zone tipica di un passato che ci appare come molto tranquillizzante e pieno di certezze se confrontato con il turbolento presente e l’inafferrabile futuro. Semplificando un po’, potremmo dire che il nostro mondo moderno è spaventoso; pieno di disastri naturali, crescente fanatismo e razzismo, guerre e malattie. Il passato era invece roseo e ben definito.


Ad ogni modo, l’attività dell’archivista contemporaneo porta con sé, dalla storia dell’archivistica, la capacità di creare nuove e inaspettate relazioni fra materiali.
Un caso ancora differente è quello di Mindy Seu e del suo corposissimo progetto Cyberfeminism Index – un sito web e una pubblicazione di 600 pagine iniziato come un semplice foglio di calcolo open source che illumina sul potenziale dell’archiviazione come strumento collaborativo, di base e socialmente radicale. Tornano qua alla mente le visioni di autori quali Pierre Levy (L’intelligenza collettiva; Feltinelli; 2002) o James Surowiecki (La saggezza della folla; Fusi Orari; 2007).

Il progetto della Seu ospita la teoria della tecnocritica, una branca della ricerca dedicata allo studio del cambiamento tecnologico. Parlo di archivio in questo caso perché il progetto nasce come foglio di calcolo che nella sua natura collaborativa, ha visto oltre il 60% del suo materiale provenire da forme di collaborazione da parte degli utenti. Il progetto dimostra – senza oramai che la cosa debba più sorprenderci – quelli che sono i nuovi modi di archiviazione più incentrati sul digitale e le forme con cui tali metodi stanno aiutando le pratiche archivistiche di base a prosperare e diffondersi. Come sostiene la stessa Seu: “L’archiviazione di base è una strategia così importante per le persone che stanno tentando di rivedere le storie”, dice Mindy, “Ci aiuta a venire a patti con l’idea di molteplici verità, piuttosto che con una singola storia oggettiva”.
Non è un caso che la Seu insista così tanto sulle parole archiviazione di base.
Ciò che infatti rende Cyberfeminism Index così diverso è infatti a mio avviso, il modo in cui esso sfida i preconcetti su cosa sia realmente un “archivio” o su come esso è stato descritto e vissuto da sempre ovvero un’istituzione che ha strutture di conservazione fisse, rigide e immutabili che si estendono attraverso le differenti generazioni che ne fanno uso, esattamente il contrario di quanto emerge nell’archiviazione di base.
“L’archiviazione di base ci aiuta a venire a patti con l’idea di molteplici verità, piuttosto che di una singola storia oggettiva”.
Anche l’attività dell’artista Esiri Erheriene-Essi è legata al tema dell’archivio visto che raccoglie immagini fin dagli anni Ottanta. Questo amore per l’accumulo di materiale visuale l’ha accompagnata fino al Master in Media Studies e poi allo stage alla BBC. Per lei l’importanza dell’archivio risiede nella sua capacità di rimettere al centro le storie dimenticate, “facendoci ricordare in questo le persone che hanno avuto un ruolo – grande o piccolo che sia – nel plasmare il mondo in cui viviamo”. In pratica, Esiri utilizza le immagini che raccoglie come fonte di ispirazione per i soggetti, i luoghi e i tema dei suoi dipinti, a volte integrandoli fisicamente nel lavoro in veri e propri collage.

Per la fotografa Daniela Spector archiviare non è solo un mezzo di espressione creativa, ma una vera e propria forma di “terapia”. Quando nel settembre 2019 è venuta a mancare sua madre infatti, Daniela si è aggrappata agli effetti personali di sua madre, le numerose foto e oggetti che aveva raccolto nel corso della sua vita. All’inizio, semplicemente con l’intenzione di ridistribuire i ricordi materni ai membri della famiglia, ma poi – in risposta a quella che lei stessa descrive come “paura di dimenticare” – ha iniziato a fotografare tutto ciò che aveva raccolto. Più tardi, si è imbattuta in un’immagine di sua madre che non aveva mai visto prima; un suo ritratto incorniciato all’interno di un cuore sotto il quale aveva scritto “Te prohibo que me olvides” ovvero “ti proibisco di dimenticarmi”. Da quel momento in poi, queste immagini hanno continuato a informare il suo progetto I Forbid You to Forget Me , una raccolta visiva composta degli effetti personali di sua madre, alcunrimasti come li ha trovati, altri rivistati dall’artista con ricami, collage e fotomontaggi.
In questo caso il concetto di archivio rimanda alla poetica warburghiana del Mnemosyne in cui si riescono a notare schemi o valori anomali, legami, relazioni, intrighi, fra ciò che lo compone. Una forma di processo con il quale sviluppare la propria alfabetizzazione visiva.

Il contesto fornito dalla pressoché infinita possibilità contemporanea di generare e manutenere archivi di ogni genere, forma e tipologia, consente agli artisti di immaginare il proprio lavoro all’interno di un contesto creativo enormemente più ampio. Proprio in questa realtà l’archivio si afferma sempre più non solo come oggetto d’indagine dell’artista e degli studiosi in genere, ma anche e soprattutto come vero e proprio medium, linguaggio e forma comunicativa con cui esprimere e diffondere messaggi.
Dopotutto è l’archivio il concetto che più si avvicina a quello di Database proposto da Lev Manovich come base della forma comunicativa tipica della contemporaneità, visto che “Dopo il romanzo, e successivamente il cinema, l’era del computer introduce il suo correlato e la narrativa privilegia come forma chiave di espressione culturale dell’età moderna il database”.
Ecco ci dunque ad interrogarci su quali forme assumerà l’archivio nel futuro più prossimo, forme che come ho tentato di dimostrare in questo breve articolo, già hanno di gran lunga superato i ristretti confini in cui storicamente l’archivio era relegato, andando incontro a linguaggi nuovi e differenti che si muovono fra la produzione grassroots e il sistema dell’arte contemporanea.


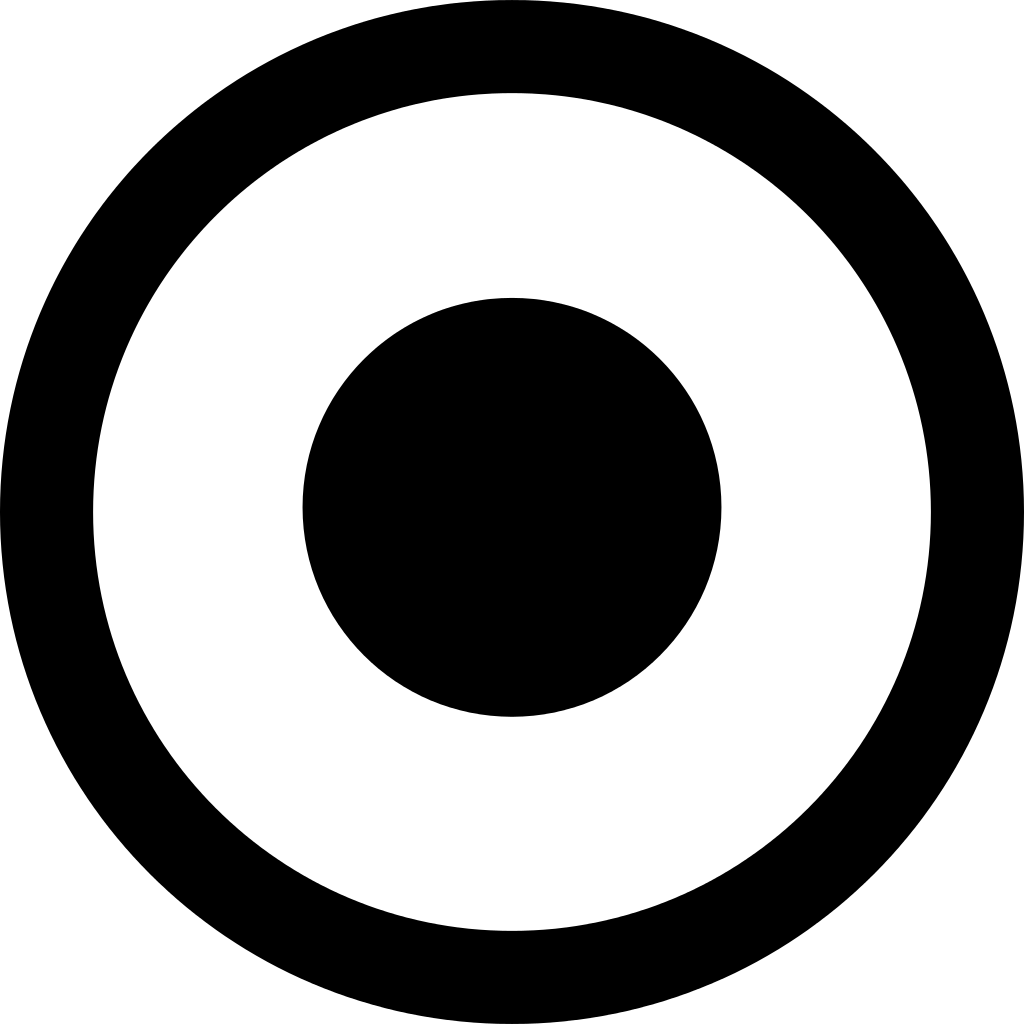 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP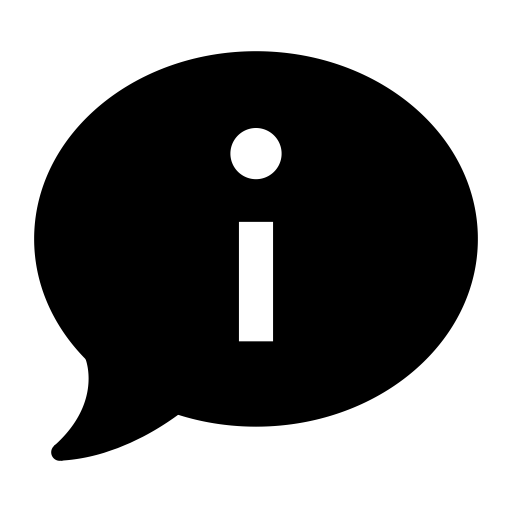 ABOUT
ABOUT 