Il trucker hat è uno di quegli oggetti che nascono senza alcuna pretesa estetica e finiscono per diventare una dichiarazione di stile, un fenomeno da massa e da élite allo stesso tempo, una di quelle derive che fanno impazzire sociologi e semiologi, i quali cercano invano di catalogarlo tra moda, sottocultura e feticcio della working class. La storia è semplice: negli anni ‘60 e ‘70, negli Stati Uniti, aziende che rifornivano agricoltori, camionisti e operai – produttori di mangimi, compagnie petrolifere, catene di ricambi auto – iniziarono a regalare cappellini con il loro logo stampato sopra. Era puro marketing di strada: un cappello funzionale, economico, con un frontale in schiuma rigida e una rete posteriore per non far sciogliere il cranio sotto il sole della Florida o del Texas. Niente di più proletario, niente di più lontano dall’idea di accessorio fashion. Eppure, come sempre succede, è nelle pieghe della casualità che nasce il mito.
Negli anni ‘80 il trucker hat è già un segno distintivo dell’America rurale, del blue-collar worker che guida il suo pickup sgranocchiando beef jerky, della country music che si mescola al rombo dei motori diesel. Poi arriva il cinema e la televisione a rafforzarne l’estetica: film come Convoy (1978) con Kris Kristofferson o la serie The Dukes of Hazzard lo rendono parte integrante dell’iconografia redneck. È l’America che non ha nulla da dimostrare, l’America delle pompe di benzina con le insegne sbiadite, delle diner aperte 24 ore, dei bicchieroni di caffè lungo e delle sigarette fumate fino al filtro. Nessuno lo indossa per sembrare cool: è solo un oggetto funzionale, una dotazione standard come il coltellino multiuso o la cintura porta-attrezzi.


E poi arriva la mutazione. Il trucker hat entra nel mondo della moda come un colpo di scena scritto da uno sceneggiatore sovversivo. È l’inizio dei 2000 quando Von Dutch – brand ispirato all’artista e meccanico hot rod Kenny Howard – prende il vecchio cappello da camionista e lo trasforma in un fenomeno pop. Paris Hilton e Justin Timberlake lo sfoggiano nei party di Los Angeles, Britney Spears lo abbina ai suoi outfit da bad girl, Ashton Kutcher lo porta ovunque, lanciando la moda come se fosse un meme ante-litteram. L’ironia della cosa è che il trucker hat, nato come emblema della classe operaia, diventa il simbolo del kitsch di lusso, dell’estetica Y2K fatta di t-shirt attillate e jeans a vita bassa. È il paradosso per eccellenza: un accessorio pensato per lavorare sotto il sole diventa un feticcio da club esclusivo.

Ma la storia non finisce qui. Nel decennio successivo il trucker hat subisce la stessa sorte di qualsiasi fenomeno culturale che viene spinto oltre il suo punto di rottura: diventa cringe, trash, un’icona di cattivo gusto da cui prendere le distanze. Nessuno lo vuole più vedere, se non nei vecchi scatti di MySpace o nei reality show di MTV. Ma come ogni oggetto nato dalla cultura popolare, ha un’elasticità che sfugge a ogni controllo. Oggi è tornato, ripreso dallo streetwear giapponese, riadottato dagli skater, rilanciato dai brand indie che giocano sullo stesso cortocircuito estetico degli anni 2000. Balenciaga lo ha riproposto con il suo solito approccio da ready-made di lusso, i rapper lo indossano con lo stesso spirito con cui un tempo avrebbero messo una catena d’oro massiccio.
E alla fine la domanda rimane: è un pezzo di storia della moda o solo un’illusione di stile riciclata dal capitalismo? Forse entrambe le cose. Forse il trucker hat è il détournement definitivo: nato come gadget pubblicitario per lavoratori veri, passato per le mani della cultura trash e infine riaccolto dal fashion system come reliquia post-ironia. E nel frattempo, negli angoli dimenticati del Midwest, ci sono ancora camionisti che lo indossano senza sapere di essere icone di una moda che va e viene come un vecchio motore diesel che non smette mai di ruggire.


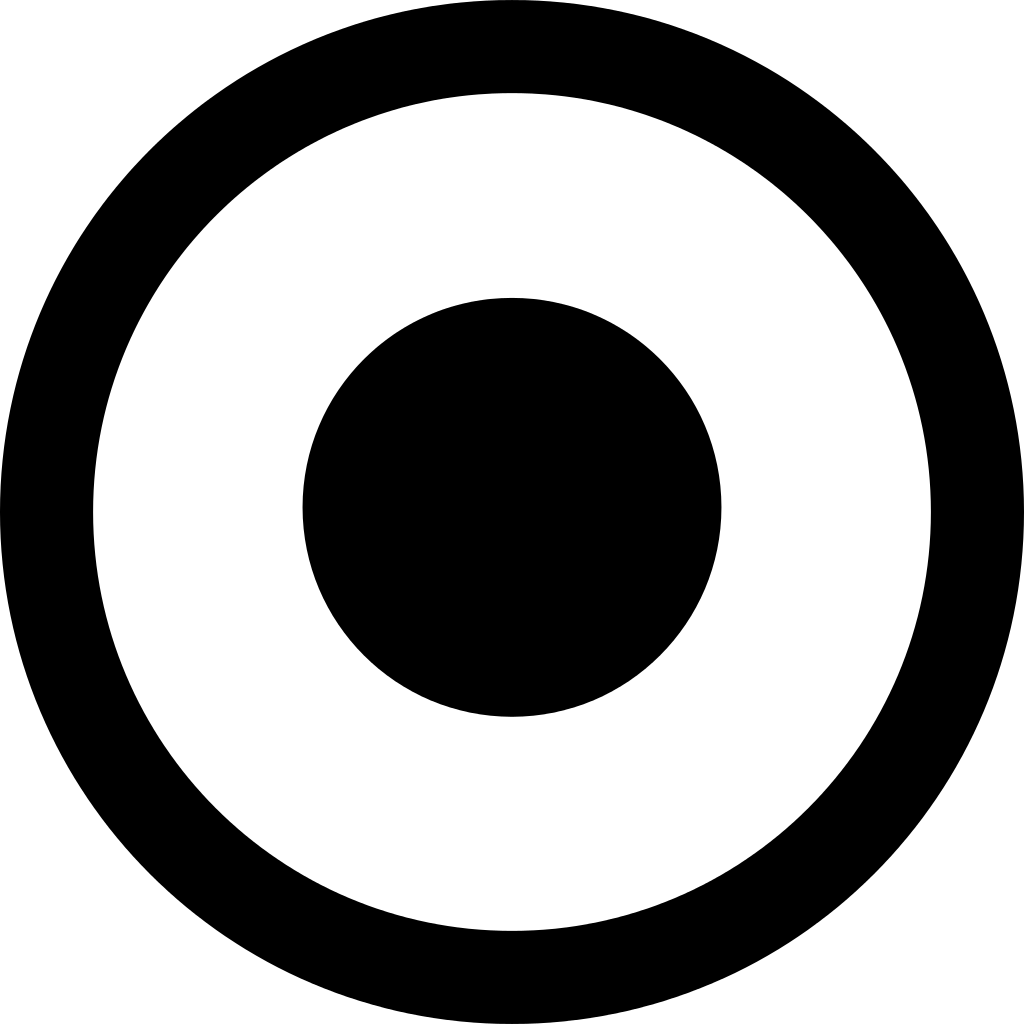 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP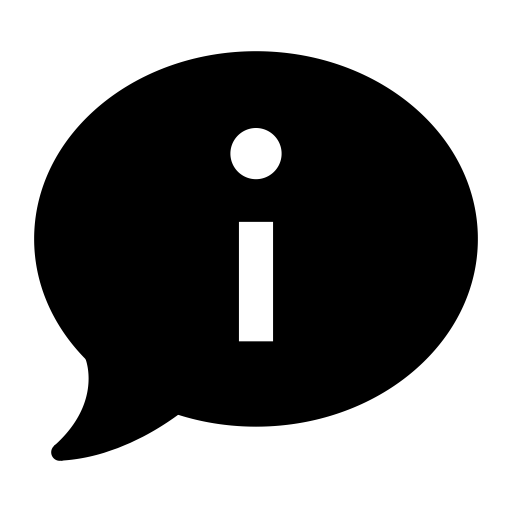 ABOUT
ABOUT 