Nel 1978, una donna piazza una videocamera davanti al televisore, registra qualche ora di Wonder Woman, poi monta il tutto in loop: trasformando le capriole e la rotazione del costume di Diana Prince in un cortocircuito ipnotico, punk, esasperato. La donna in questione è Dara Birnbaum, e da quel momento la storia dell’arte, della televisione e della critica visiva non è più la stessa.



Perché la Birnbaum ha fatto qualcosa di totalmente inedito all’epoca: ha smontato il linguaggio massmediatico dall’interno. Come una terrorista culturale col cacciavite, ha preso le immagini più rassicuranti, le ha fatte esplodere, e poi le ha rimontate in modo disturbante. Nessuna predica, nessun museo bianco: solo montaggio, ritmo, fastidio e gloria.
CONTESTO: TELEVISORE COME CAMPO DI BATTAGLIA
Siamo nella New York dei tardi anni 70, in pieno postmodernismo, quando il video diventa linguaggio d’assalto. Mentre la TV americana sforna sit-com rassicuranti e format militarizzati (talk show, soap opera, game show), una nuova generazione di artisti prende il monitor come superficie da graffiare. Dara Birnbaum non viene dal mondo dell’arte pura, ma dall’architettura e dall’ingegneria elettronica. Tradotto: ha occhio per lo spazio e cervello per le macchine. Si forma alla Carnegie Mellon e poi si muove tra le gallerie sperimentali di Manhattan e le comunità femministe, dove si inizia a pensare al video come linguaggio critico femminile. Il suo non è documentario; non è cinema, ma qualcosa di nuovo, irregolare, e soprattutto: antitelevisivo.
ESTETICA DA TAGLIO LASER
Il tratto distintivo di Birnbaum è il montaggio chirurgico. Le sue opere sembrano glitchate prima che esistesse il glitch. Prendono la fluidità rassicurante della TV e la impastano con il ritmo compulsivo del loop, la ripetizione come forma di tortura e di rivelazione. Ogni frame è scelto, sezionato e ripetuto fino a diventare un grido muto, isterico, quasi dadaista. Nel leggendario Technology/Transformation: Wonder Woman (1978-79), la metamorfosi dell’eroina diventa loop ossessivo, svuotato di significato: non empowerment, ma automatismo. La trasformazione come prigione. La donna come gif preistorica, schiava del proprio potere pop. Birnbaum usa caratteri bold, transizioni brutali, bande colorate, sovrimpressioni grafiche prese dal mondo dei telegiornali. Tutto l’impianto visivo delle sue opere è violento, disturbante, incastrato tra citazione pop e sabotaggio. È grafica editoriale che si è liberata dalla pagina. È Max Headroom con la PMS. È MTV decomposta prima che MTV esistesse.
CHI C’ERA ATTORNO E CHI C’È OGGI
Birnbaum non è sola. Nello stesso periodo, artisti come Joan Jonas, Nam June Paik, Shigeko Kubota, Vito Acconci e Dan Graham ridefiniscono l’uso del video. Ma è lei che più di tutti prende la lingua della televisione commerciale e la perverte con sapienza chirurgica e rabbia lucida. E oggi? Il suo lascito è ovunque. In artisti come Hito Steyerl, nei meme hipercinetici dei social, nei remix visivi delle culture post-YouTube, nel linguaggio di TikTok e dei video essay, che smontano e ricostruiscono immagini culturali in tempo reale.
PER CONCLUDERE?
Dara Birnbaum non ha semplicemente “fatto videoarte”. Ha fatto autopsie visive. Ha aperto il petto alla televisione e ci ha infilato le mani dentro, tirando fuori i suoi nervi, le sue bugie, il suo ritmo assassino. E se oggi sei su Instagram a guardare per l’ennesima volta un loop di tre secondi in cui qualcuno si trasforma in drag queen aliena, o un politico viene glitchato fino a sembrare un demone del marketing… beh, Birnbaum ci aveva già pensato. Col dito sul REC e l’altro medio alzato verso la cultura pop.




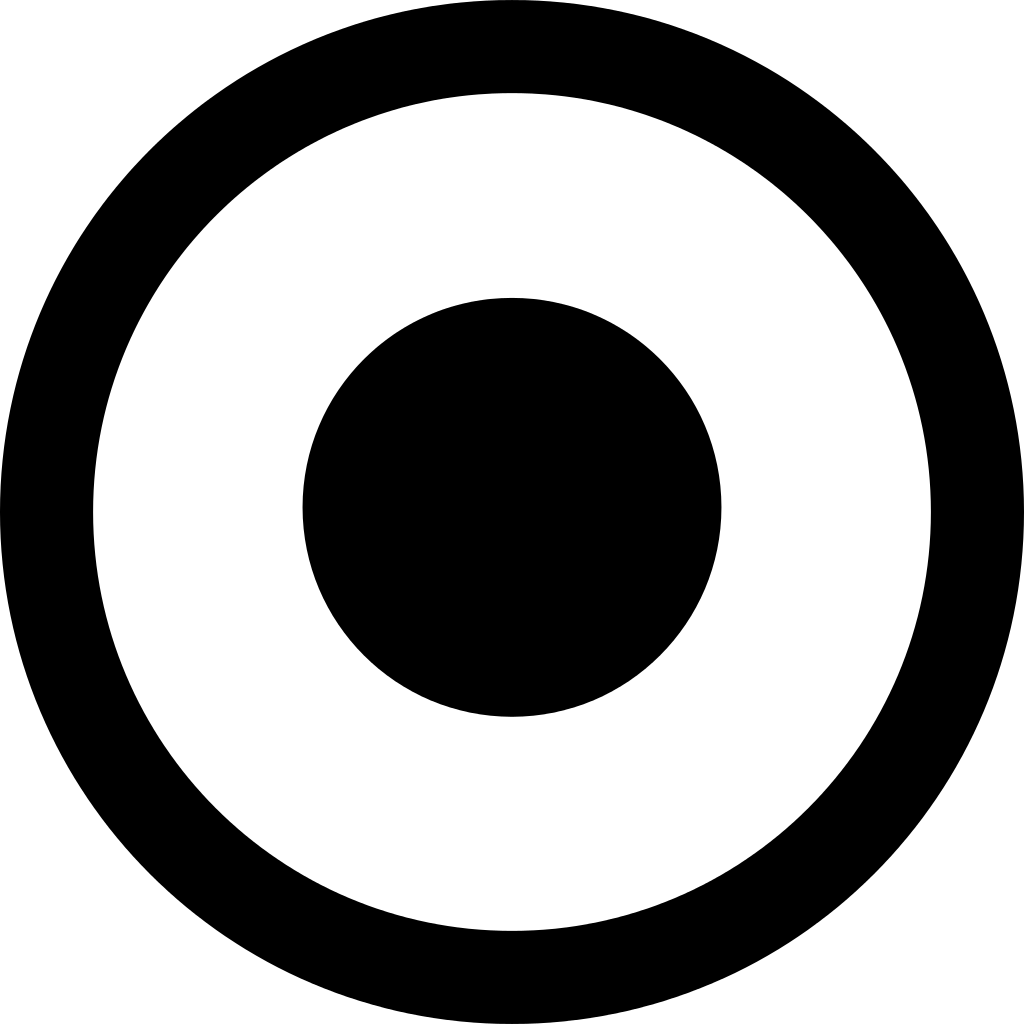 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP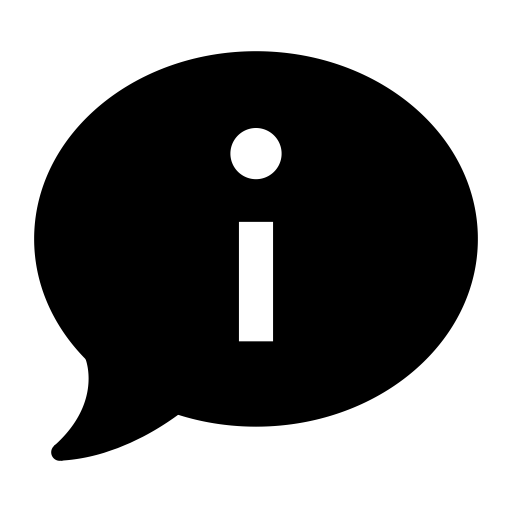 ABOUT
ABOUT 