C’era questa sera, non molto tempo fa, in cui ero solo, fuori faceva caldo e buio, e nelle cuffie mi è arrivata L’ultima cosa oltre l’amore di Giovanni Truppi. Non so nemmeno perché l’ho messa in play, forse per caso, forse per istinto. Ma so che, quando è arrivato il finale – “È quella cosa che ci divide / Tra chi simpatizza con chi vince e dall’altra parte / Ovunque da sempre e per sempre / Chi simpatizza con chi perde” – mi sono fermato. Non solo con il corpo. Ho sentito che c’era qualcosa che mi stava passando accanto e che non voleva farsi acchiappare. Una malinconia densa, quasi stanca. Un senso di verità che si mescola col veleno della rassegnazione. Perché quel finale, ogni volta che lo ascolto, mi resta in gola come una promessa spezzata: bella, sì, ma zoppa. Una carezza che arriva tardi, dopo la fucilazione, dopo l’esilio, dopo l’archiviazione.


E ho pensato: cos’è davvero quella “cosa” oltre l’amore? È ideologia? È coscienza? È memoria? È la parte di noi che ci fa prendere posizione? Che ci fa schierare con chi non ha potere, con chi cade, con chi scompare? È lo stesso tono che ritrovo – anzi: che rincorro – nelle poesie partigiane antifasciste. Lo stesso brivido tra il sogno e la condanna. Quelle poesie, come quella canzone, non hanno mai la soddisfazione del trionfo. Non raccontano vittorie, raccontano chi ha tenuto duro mentre tutto crollava. Raccontano chi si è portato la dignità nella tomba e chi ha lasciato due righe scarabocchiate su un pezzo di cartone come unico testamento. E allora sì, capisco Truppi: quella “cosa” è la linea che ci divide, che ci schiera, che ci inchioda al fatto che non siamo neutrali, mai. E capisco anche perché non riesco mai a godermi quel finale con leggerezza. Perché non c’è niente di leggero in ciò che ci definisce nel profondo. E perché le parole – quelle vere – non sono mai innocue.


Le poesie partigiane non parlano ai vincitori. Non chiedono medaglie. Non vogliono nemmeno essere ricordate, se ricordare significa metterle in una teca. Quello che vogliono è restare vive. Come quella “cosa” senza nome. Che ci guarda, ogni giorno, e ci chiede da che parte stiamo. Anche adesso. Anche se fingiamo di non sentire. La poesia partigiana antifascista non nasce nei salotti. Non la trovi nei licei classici né nei teatri municipali. Nasce col sangue in bocca, sotto le bombe, nelle celle, nei rifugi di fortuna, nei cessi ghiacciati delle montagne. È roba scritta in fretta, spesso a memoria, a volte con l’inchiostro, più spesso con la paura. La poesia dei partigiani non chiede permesso: spara. È figlia di un’Italia sfondata, schiacciata tra il crollo del fascismo e l’arrivo degli americani, tra i rastrellamenti nazisti e le vendette da quattro soldi. Non ha stile, ha urgenza. Non cerca il Nobel, vuole solo che qualcuno sopravviva abbastanza da ricordare un nome, un volto, una canzone. È difficile dire chi l’abbia iniziata. Forse un contadino che scrive due righe per sua madre prima di essere fucilato. Forse una staffetta che canta di notte per scacciare la morte. Poi qualcuno comincia a raccogliere i pezzi. A Torino, a Milano, a Roma. Calvino, Fortini, Pirelli. Gente con le mani sporche di stampa e le tasche piene di comunismo. Cominciano a mettere insieme i versi, a pubblicarli. Ma non è poesia da antologia: è roba che brucia. Ogni parola pesa quanto un colpo di moschetto. Ogni rima è una cicatrice.
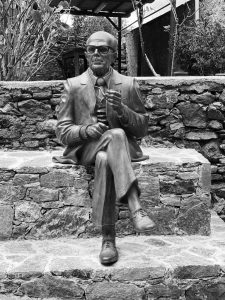

Nel dopoguerra, tra il ’45 e il ’50, l’Italia fa finta di ripulirsi. Ma le poesie restano lì, come proiettili inesplosi. Einaudi ne stampa una raccolta, i Dischi del Sole le trasformano in canzoni, i militanti le leggono come vangeli. Non sono liriche, sono reportage poetici da un mondo che non esiste più ma che continua a mordere. I veri autori restano sconosciuti. Morti. O troppo vivi per mettersi a firmare. Poi arrivano gli anni Settanta. E la Resistenza diventa di nuovo polvere da sparo. Nei centri sociali, nei cortei, nei giornali ciclostilati, le poesie partigiane ritornano. Ma sono cambiate. Adesso gridano dentro le fabbriche, tra i lacrimogeni, nei dischi punk, nelle strofe rap. La lotta non è più contro i fascisti in divisa, ma contro i padroni in giacca e cravatta. E quelle vecchie poesie di montagna diventano ancora armi, tradotte in slang urbano, in linguaggio di strada. Nessuno le studia, ma tutti le cantano. Sotto la retorica, sotto il marmo delle lapidi, c’è ancora la voce sporca e tagliata di chi scriveva per non morire del tutto. Perché se non puoi sparare, almeno puoi scrivere. E se scrivi, sei ancora vivo.
Oggi ne trovi tracce ovunque. In un graffito su un muro, in un verso sputato su un palco, in una pagina sgualcita in una biblioteca che nessuno frequenta più. Non sono poesia civile. Non sono folklore. Sono vene aperte, ancora calde, sotto l’asfalto di questa Repubblica stanca. La Resistenza non è un monumento, non è una ricorrenza. È il sangue che scorre. È il gesto che si ripete ogni volta che qualcuno dice no. Non ha vinto per sempre, ma non ha mai smesso di combattere. E non perderà mai, finché ci sarà qualcuno che sa ancora leggere un verso come si tiene un colpo in canna.


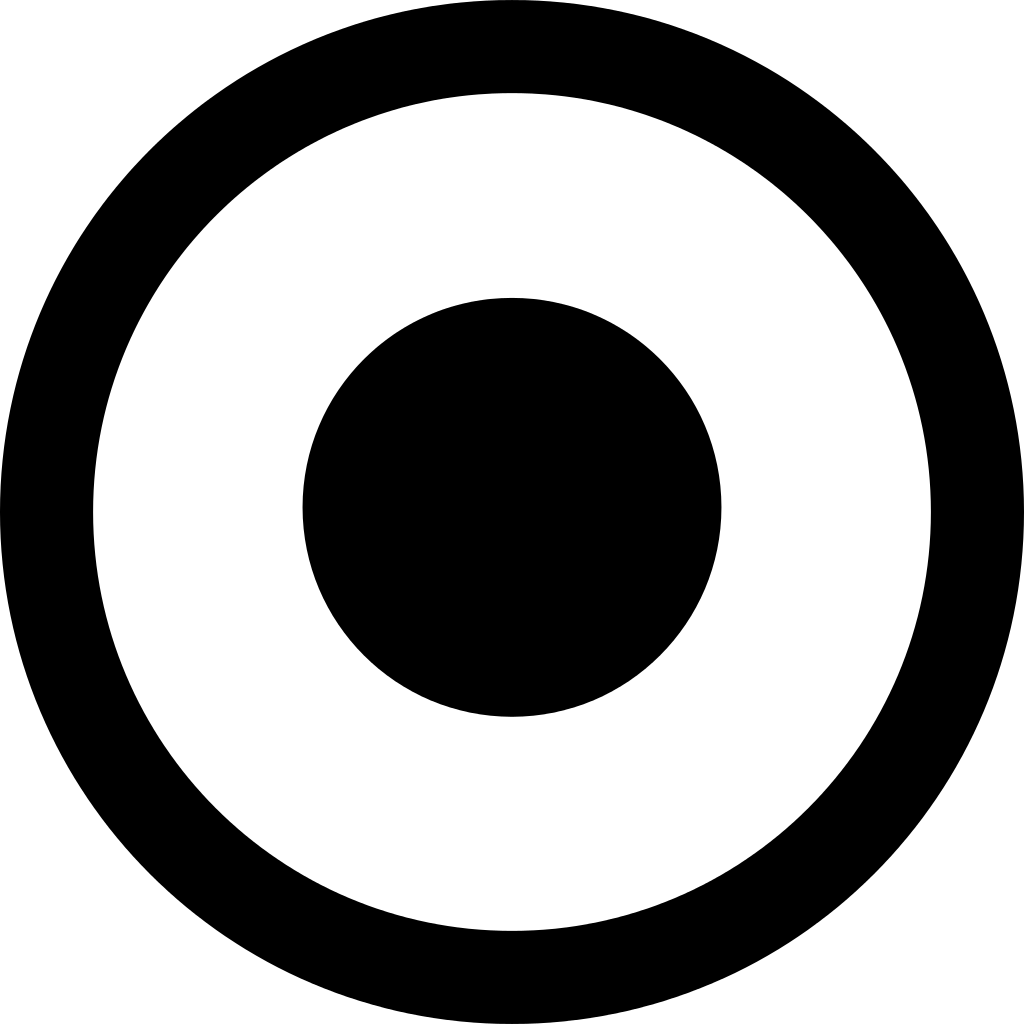 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP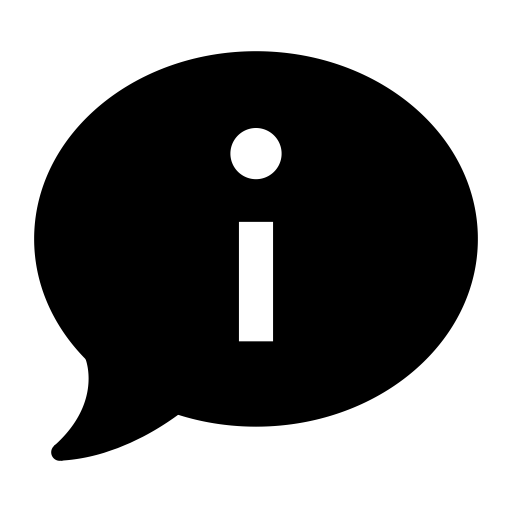 ABOUT
ABOUT 