Un articolo ispirato, ampliato e criticamente intrecciato con l’estratto di W. David Marx su The Atlantic il 25.11.2025.
Nel 2009, Fredric Jameson scriveva che il postmoderno viveva di “pastiche senza profondità”, una citazione che oggi ritorna come un eco profondo e un po’ inquietante. Quindici anni dopo, lo scenario che descriveva sembra diventato non solo il linguaggio dell’arte contemporanea, ma la grammatica stessa del nostro vivere culturale.
Siamo immersi in un ambiente che produce contenuti senza tregua — tutti intercambiabili, tutti bruciati in pochi minuti. Nel leggere, recentemente, l’estratto del nuovo libro di W. David Marx, Blank Space, pubblicato su The Atlantic, la sensazione è che questa “fenomenologia della saturazione” non sia solo una diagnosi accademica, ma una condizione esistenziale.
Marx sostiene infatti che il vero problema non è riconducibile all’eccesso di produzione culturale, ma alla sua incapacità di generare rotture. In un mondo in cui tutto può essere remixato, appropriato, ricodificato, la cultura sembra aver perso la tensione verso il nuovo. È l’inerzia che Mark Fisher chiamava “lento cancellarsi del futuro”, quella la sensazione che non potrà emergere niente che non sembri già successo. Fisher lo applicava alla musica — nessuno più inventa un suono, si inventano solo nostalgie — ma è un’idea ormai esportabile ovunque.
Il paradosso è che abbiamo più strumenti, più mezzi, più possibilità di sperimentare rispetto a qualsiasi altra generazione, ma meno capacità di produrre ciò che davvero rompe, devìa, crea uno scarto.

È interessante confrontare l’analisi di Marx con posizioni opposte, come quella di Douglas Rushkoff, che in Present Shock sosteneva che il problema non è l’assenza di futuro, ma la tirannia del presente: tutto è qui, ora, compresso in un istante eterno. Rushkoff vedeva in questa orizzontalità una potenzialità liberatoria; Marx, al contrario, la legge come una paralisi. Eppure, entrambi concordano su un elemento cruciale:
la digitalizzazione non è stata solo un cambiamento tecnologico, ma una trasformazione antropologica. Ha cambiato il modo in cui immaginiamo il tempo.
L’arte contemporanea sembra confermare questi segnali. Pensiamo a figure come Amalia Ulman, la cui performance Excellences & Perfections ha mostrato come identità e narrazione siano oggi materiali di costruzione più che territori da esplorare. O agli scultori digitali come Jon Rafman, che setacciano il cyberspazio più per archiviarne i fantasmi che per costruire mondi nuovi. O ancora agli artisti NFT della prima ora, la cui grande promessa di rivoluzione è stata rapidamente risucchiata dentro la più antica delle dinamiche: la speculazione.
In ambito musicale, artisti come Arca e Yves Tumor insistono con coraggio su ibridazioni radicali, ma rimangono isole, eccezioni brillanti, ancora incapaci però di generare un vero e proprio movimento. La sensazione generale è quella di una grande stanchezza formale, un contesto in cui persino ciò che appare sperimentale spesso non fa altro che giocare con codici già noti. Marx, nel suo testo, invita a recuperare una mentalità “pre-kitsch”, per usare una formula sintetica: un atteggiamento disposto a mettere in discussione le forme più che a riprodurre estetiche riconoscibili. È una proposta che si avvicina, per certi versi, alle idee di Boris Groys, quando afferma che
l’arte veramente contemporanea non è quella che produce nuove immagini, ma quella che produce nuovi regimi del visibile.
Ma questa prospettiva è fragile. Significa non soltanto proteggere l’avanguardia, ma creare le condizioni perché possa emergere e questo è oggi il punto più critico.

Il mercato culturale — lo sappiamo dai tempi di Theodor W.Adorno, ma oggi con esiti aggravati — non premia la complessità, premia invece ciò che può essere dirompente senza essere difficile, controverso senza essere realmente scomodo, strano purché gestibile. E così, paradossalmente, l’industria culturale produce una dose controllata di eccentricità, una stravaganza sterilizzata che non minaccia alcun ordine. È il motivo per cui personalità come Ye, Elon Musk o Donald Trump finiscono per incarnare, nel bene e nel male, un’idea di “genio culturale” non per ciò che creano, ma per ciò che muovono.
Sono contenuti viventi, forme di rumore istituzionalizzato che sostituiscono l’arte con la performance continua.
Pensa a un’opera d’arte che diventa virale più per lo scandalo che per il suo contenuto, o a una mostra il cui unico scopo sembra essere generare hashtag e polarizzare l’opinione online. Questi non sono più semplici lavori culturali, ma “contenuti viventi”: organismi progettati per nutrirsi di attenzione e riprodursi nelle discussioni. Il loro meccanismo – il rumore – è così previsto e sistematico da essere diventato una prassi istituzionale. In questo processo, l’arte (fatta di silenzio, contemplazione, significato) viene rimpiazzata dalla sua performance mediatica perenne, che deve sempre essere “accesa” per giustificare la propria esistenza.
Per comprendere questo spostamento, può essere utile ricordare le teorie di Neil Postman sulla spettacolarizzazione dell’informazione: quando tutto deve intrattenere, tutto perde significato, e quando il significato scompare, l’unico criterio rimasto è la visibilità. In questo senso l’analisi di Marx non è nostalgica, ma pragmatica:
non possiamo aspettarci che il mercato, da solo, produca il nuovo. Il mercato non innova, consolida. Il mercato non rischia, replica.
L’innovazione — quella vera, quella costosa, quella che spesso fallisce — nasce da comunità ristrette, autonome, a volte persino antagoniste. È qui che il discorso si intreccia con le subculture contemporanee. Esistono ancora veri margini? Sì, ma spesso non sono più spazi fisici. Molte micro-scene creative vivono dentro server come Discord, archivi criptati, newsletter indipendenti, cartografie di reti semi-private. Pensiamo alla scena post-internet che si sviluppa intorno a The Wrong Biennale, o ai collettivi come New Models, che cercano di pensare una cultura non allineata alle logiche delle piattaforme.
Il problema è che l’ambiente digitale tende a rendere immediatamente visibile ciò che prima poteva crescere in silenzio. La lentezza, l’opacità, il segreto — che sono parte necessaria di qualsiasi avanguardia — sono diventati quasi impossibili da praticare.

Qui le idee di Marx dialogano sorprendentemente con quelle di Anna Lowenhaupt Tsing, la quale in The Mushroom at the End of the World descrive l’avanguardia come un ecologia, non come un movimento. Una foresta complessa fatta di simbiosi, contaminazioni, radicalità marginali. E forse oggi dovremmo pensare davvero la cultura come un ecosistema, non come una timeline che scorre. Il suo appello a creare un terroir culturale significa proprio questo: servono ecosistemi vivi, non piattaforme. Serve un terreno che protegga le differenze senza trasformarle in prodotti immediati. Il che non implica romanticizzare il margine. Le micro-scene creative sono sempre state fragili, precarie, spesso autodistruttive. Ma erano anche laboratori di immaginazione. Non si tratta di replicare il passato: non avremo un nuovo punk perché non esiste più il mondo che l’ha generato. Ma possiamo generare uno strappo analogo, se accettiamo l’idea che la cultura viva nella tensione, non nella ripetizione. In questo senso, il discorso di Marx si avvicina alle riflessioni di Claire Bishop sulla necessità di un’arte che non si limiti a “interagire”, ma che torni a essere conflittuale, storicamente situata, antagonista. La cultura non si muove se non incontra resistenza. E oggi la resistenza non è tanto contro il potere politico, quanto contro l’indifferenza algoritmica. Alla fine, ciò che quest’analisi chiede al lettore è una decisione. Non possiamo delegare la responsabilità del futuro culturale alle grandi piattaforme, ai critici compiacenti o ai trend virali. La domanda è un’altra: siamo disposti a sostenere opere che non hanno ancora un valore? A dare spazio a forme che non promettono successo, ma solo rischio? A rendere di nuovo possibile la stranezza?
Forse il futuro della cultura dipende da questo: dalla nostra capacità di non desiderare solo ciò che possiamo già capire. Dalla disponibilità a essere spettatori meno comodi e più curiosi. Dalla volontà di lasciare che qualcosa — qualcuno — si sviluppi fuori dagli occhi del mondo, nel buio fertile da cui è sempre nata ogni vera novità.
Tutte le immagini sono ©️Filip Hodas


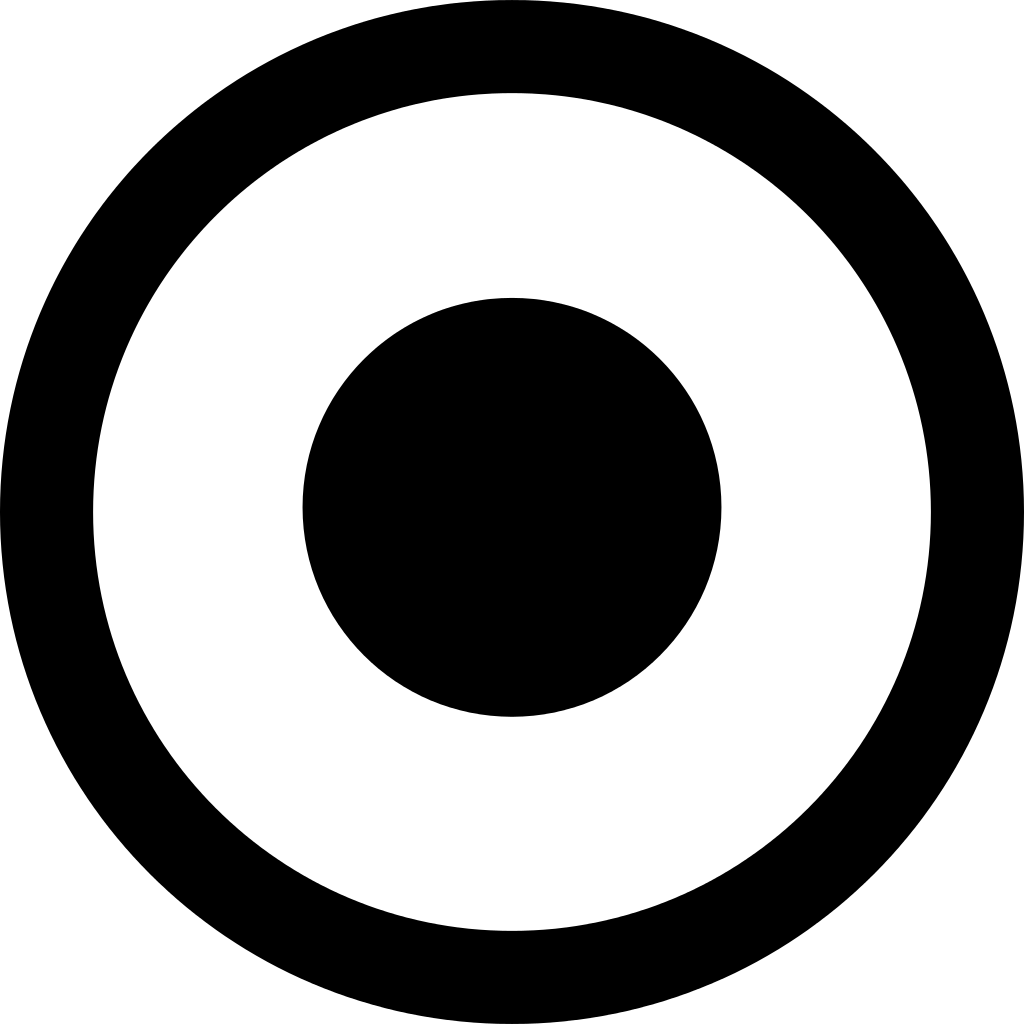 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP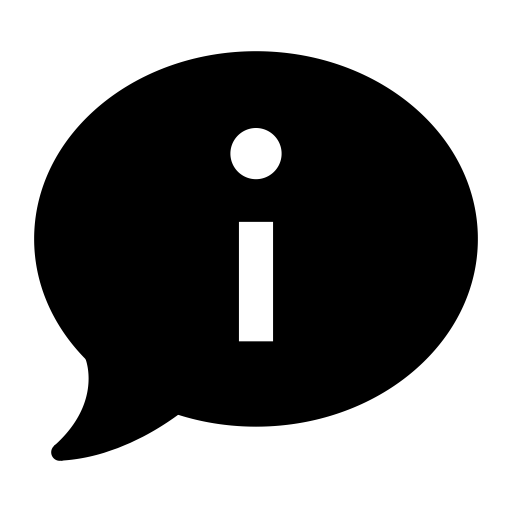 ABOUT
ABOUT 