Continuiamo a cercare di indagare come si stia evolvendo la comunicazione indipendente all’interno dello scenario di guerra ucraino e affrontiamo un tema che, giorno dopo giorno, è emerso sempre più chiaramente. Uno degli aspetti infatti di questa guerra che, sia per la vicinanza geografica e soprattutto culturale, sia per la dimensione eccezionale dei fatti e della tragedia, è fin dal primo giorno un conflitto avvertito in tutta Europa come differente è la sua enorme copertura mediatica.
Prima di avanzare con il mio scritto corre l’obbligo di due brevi precisazioni:
– non intendo trattare di temi che possano essere ricondotti in qualche misura ad approcci soggettivi quali la partigianeria e il tifo da stadio. Non mi interessa qua analizzare le ragioni di chi ha attaccato e di chi si sta difendendo. Esistono altri canali per farlo.
– non intendo soffermarmi sull’ingente mole di comunicazione che può essere definita come “propaganda“, termine che – è sempre bene sapere – deriva dall’unione del suffisso pro (avanti) e dal verbo pagàre (fissare, piantare, consolidare.). Anche in questo caso esistono altri canali per farlo.

Irpin, nord ovest di Kiev, Ucraina. (foto di Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images)
Sgombrato il campo (spero) da potenziali divagazioni sul tema, torniamo alla vastissima copertura mediatica del conflitto in Ucraina.
Riannodando un po’ le fila, possiamo con una certa dose di tranquillità, sostenere che come ogni altro ambito della comunicazione, anche il giornalismo di guerra segue il ritmo delle innovazioni tecnologiche e quindi, se nella nella guerra dei Balcani (1995) potevamo dare libero sfogo al nostro naturale istinto informativo (e voyeuristico) tramite un numero mai visto di immagini fotografiche è nella cosiddetta Seconda Guerra del Golfo (2003) che ci ritrovammo sorpresi di poter vedere in diretta la contraerea irachena tentare di rispondere agli attacchi aerei degli Stati Uniti. La Cecenia, l’Afghanistan, la Siria, la Libia ci hanno portato nelle nostre case le strazianti immagini di distruzioni a tappeto e scontri senza esclusioni di colpi ma con una pur irregolare e talvolta disinteressata regia dei canali mainstream che mantenevano sul campo una certa presenza logistica e organizzativa.
Molto poco sappiamo invece, da un punto di vista di copertura mediatica, degli altri molteplici conflitti che insanguinano il globo.
Da questo punto di vista la guerra in Ucraina ha ulteriormente segnato un cambio, una rottura delle dinamiche comunicative fra il giornalismo e lo spettatore attraverso alcune figure mai del tutto conosciute in precedenza e che, adesso, sono divenute centrali e imprescindibili per raccontare gli scenari di guerra. Proprio di queste figure, i cui nomi sono familiari solo a chi opera direttamente nel settore broadcasting, vorrei parlare.
Innanzi tutto è oramai chiaro che la guerra in Ucraina è territorio – direi esclusivo – dei giornalisti freelance, in italiano traducibile con un generico libero professionista. Ne abbiamo visti e li abbiamo imparati a conoscere, ci siamo domandati come sia la vita quotidiana di queste donne e uomini che per lavoro devono essere lì, proprio lì dove imperversano gli accadimenti.
Rispetto ai conflitti precedenti sono loro i nostri occhi, le nostre orecchie, i nostri corpi sul terreno di guerra con tutti i rischi e le emozioni che questo comporta. Sono freelance, lavoratori senza tutele, come li definisce Toni Capuozzo, giornalista e inviato di guerra in un’intervista a MOW in cui sottolinea come:
nella televisione italiana la guerra deborda nei contenitori mattutini, pomeridiani e serali, invade tutto il palinsesto e questo cambia anche il lavoro di chi si trova sul campo, impegnato più nel doversi districare tra un collegamento e un altro che nel fare il suo mestiere.
Sempre nell’intervista Capuozzo sottolinea anche come: «Quello di andare a raccontare sul posto i conflitti è un lavoro che non si fa senza passione, e nei tanti freelance in Ucraina vedo una passione fortissima, sicuramente irragionevole se pensiamo al tornaconto economico, ma anche al fatto che sono inermi sotto l’aspetto assicurativo e pure rispetto al sostegno giornalistico redazionale».
Rispetto all’estero, la comunicazione si fa trasmettendo sempre più live, poi se ne discute in una logica binaria, o con o contro, come se fosse una nomination, in TV come sui Social Network o nel dibattito politico.
Sul terreno di conflitto si è tutti uguali. Ma formalmente e burocraticamente non è così: esistono gli inviati ed esistono i freelance.
Quello che si vede oggi è figlio di un processo lungo che ha visto scomparire la figura dell’inviato, principalmente per questione di costi. Per paradosso, ora si possono inviare immagini e corrispondenze anche solo grazie allo smartphone, senza più bisogno ad esempio del satellite, eppure sono i costi assicurativi a pesare di più. Da questo punto di vista le redazioni delle testate sono riluttanti, perché è molto costoso ed è impegnativo anche dal punto di vista morale inviare i giornalisti e allora preferiscono appaltare il lavoro sporco ai freelance.
Utili sì, ma a proprio rischio e pericolo, I freelance sono soffocati dalla miseria del mercato giornalistico.
I freelance possono reggere fino a un certo punto, poi diventano quasi dei missionari. Questo è un meccanismo perverso: ci sono coraggiosi e bravi freelance per i quali è andare sul campo è occasione di rivincita su tempi magrissimi, ma nelle logiche di questo giornalismo sappiamo bene che sino a tre mesi fa, se qualcuno avesse proposto un servizio sui rischi di una guerra in Ucraina, non sarebbe stato probabilmente capace di venderlo a nessuno. Proprio quesa scarsa propensione a coprire gli scenari fino a che non esplode la notizia, fa sì che ormai pochissimi siano i giornalisti che hanno esperienza di questo tipo.
Ma ad affiancare i freelance sul campo esistono anche altre figure, di solito meno conosciute, che lavorano dietro le quinte anche per ragioni di sicurezza personale e che dimostrano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, quanto necessaria e vitale sia l’esistenza dell’editoria indipendente che troppo spesso, nel nostro apparente stato di calma e impermeabilità ai conflitti, releghiamo a mero fenomeno di costume.
Ecco dunque che emerge la figura del fixer – o risolutore in italiano – che l’agenzia di stampa italiana AGI definisce come:
Quelle persone che negli scenari di guerra come nelle inchieste di mafia, assistono i giornalisti che si muovono sul campo. Conoscono la lingua, gli usi locali, i personaggi chiave e il loro è un ruolo da dietro le quinte, ma non per questo meno pericoloso.
I fixer creano un rapporto umano molto intenso con il freelance che affiancano.
Come ha giustamente sottolineato Bobby Gosh, editorialista per CNN e MSBC, non esiste un sistema di ricompense strutturato per i fixer, non esiste una casistica legale strutturata e definita eppure sono anch’essi esposti in prima linea affianco al freelance. I fixer corrono rischi enormi, e anche le loro famiglie, per questo è necessario che le testate e gli editori si assumano la responsabilità di fornire loro gli strumenti per essere più sicuri possibile.
Stando a quanto scritto dal sito dell’European Journalism Osservatory facendo riferimento al libro della ricercatrice americana Lindsay Palmer dal titolo The Fixers: Local News Workers and the Underground Labor of International Reporting (Oxford University Press, 2019): «I fixer sono attori dei media locali che vengono assunti dai giornalisti come traduttori, guide e per vari lavori di supporto».
I fixer percepiscono il loro ruolo prevalentemente come performativo, come una sorta di mediatore, un traduttore e interprete che si pone in una posizione intermedia fra culture, lingue e contesti locali differenti. Lavorano quindi nel punto di contatto tra il locale e il globale e si muovono nella costante tensione informativa tra la comprensione e l’incomprensione, tra il collegamento e la separazione, tra la vicinanza ai fatti che avvengono sul campo e l’iper-estensione mediatica delle informazioni globali. In questo modo, contribuiscono alla produzione della cultura e alla sua mediatizzazione, nel senso in cui la intende il sociologo Stuart Hall.
I fixer sono solitamente coinvolti nella preparazione di un articolo giornalistico, ma non nel processo definitivo di scrittura o di produzione. Essi occupano uno dei ranghi più bassi nella gerarchia del mondo dell’informazione internazionale e il loro ruolo è stato finora trascurato anche dalla ricerca teorica sul giornalismo contemporaneo, dice sempre la Palmer, che mette in evidenza il potenziale conflittuale del ruolo di fixer che si esplica, per esempio, quando un giornalista decide di realizzare una narrazione basata su di un’idea di storia preconcetta e stereotipata e non vuole essere dissuaso da essa; oppure quando non seguendo le indicazioni del fixer, il giornalista si comporta in modo inappropriato con le fonti mettendo in questo modo a repentaglio la vita dell’intero gruppo di lavoro dato che il fixer, a differenza del corrispondente, spesso proviene dal territorio e proprio per questo motivo non può lasciare il contesto in qui solitamente vive e lavora rimanendo esposto a un pericolo che non si esaurisce in un arco di tempo più o meno lungo con la spedizione giornalistica.

Giornalista che documenta gli eventi in piazza Indipendenza. Kiev. Febbraio, 2014. (foto Getty Images)
Le strutture con cui è composto il mercato editoriale si riflettono per forza di cose nell’organizzazione del mondo dei media globali influenzandone anche e soprattutto il rapporto tra reporter freelance e fixer. Da qui, sono spesso gli interessi delle principali aziende editoriali a decidere la scelta degli argomenti e l’inquadramento di una storia anche se, è bene precisare, che allo stesso tempo, la loro competenza locale conferisce ai fixer un’autorità che li rende indispensabili per la produzione di notizie e conferisce loro un’influenza assai rara. Un fixer può garantire infatti a un reporter l’accesso ad aspetti poco trattati di un argomento, o può contribuire a superare una problematica logistica o semplificare una situazione di stallo sul campo.
Esiste poi un ulteriore ruolo nel panorama editoriale indipendente, quello degli stringer, i cui nomi raramente vengono citati, anche se a volte sono co-autori o co-produttori di lavori giornalistici e a volte lavorano sotto contratto con aziende di Media Communications.
Sul sito Stringerguide.com lo stringer viene definito come:
essenzialmente un team di segnalazione composto da una sola persona che gestisce tutti gli aspetti del lavoro, dall’intervista alle fonti allo scatto di foto e video in loco. Stringer freelance. In molti casi, il primo vero lavoro che un giornalista esegue sul campo è proprio quello dello stringer.
Sempre sul sito si legge che gli stringer: «hanno paura di andare, ma vanno comunque». Assumono incarichi che i giornalisti regolari di solito non sono inclini ad accettare a causa degli enormi rischi e invece di ricevere uno stipendio per i loro contributi come giornalisti, solitamente devono negoziare il prezzo con più testate editoriali proponendo la propria storia e i materiali video e fotografici dal teatro di volta in volta interessato. Pensate ad un video di un incidente apparso più o meno contemporaneamente su diverse testate giornalistiche ma proveniente sempre dalla stessa fonte, ecco, in quel caso ci sono buone probabilità che la fonte sia proprio uno stringer.
A differenza di uno stringer, un fixer non scrive e non produce direttamente il contributo portando all’attenzione degli studiosi dei media – indipendenti e non – la questione di dove finisce il suo contributo denominato solitamente news fixing. A che punto cioè il fixer si distacca dal lavoro del freelance lasciandogli la storia in cui ha investito tanta pianificazione, lavoro e competenza e soprattutto rischio personale? Sempre secondo il testo della Palmer, alcuni fixer lavorano attivamente per cancellarsi da una storia dopo averla studiata e vissuta in prima persona, tagliando ogni legame tra loro e il prodotto giornalistico finale. Ma quindi, chi è davvero il produttore di quella storia?
Alcuni fixer hanno dichiarato che considerano il loro ruolo finito quando vengono pagati, che loro per primi non si vedono come giornalisti, o addirittura che vogliono avere meno responsabilità possibile sul prodotto editoriale pubblicato rispetto a quella riconducibile alla persona che lo firma. Ovviamente questo approccio risente della garanzia del loro anonimato e di conseguenza della loro sicurezza personale e comporta un onere minore di responsabilità anche futura soprattutto in quei contesti in cui vige una limitata libertà di stampa. Altri fixer, diversamente, sottolineano quanto sia importante per loro essere coinvolti nella costruzione della storia per essere apprezzati come parte integrante del contributo editoriale. In questo caso ad essere centrale è invece la loro volontà di non essere invisibili e quindi rendere utilizzabile lavorativamente parlando il proprio ruolo di contributors editoriale.

Giornalisti corrono ai ripari durante bombardamenti a Irpin, vicino Kiev. (foto Carlos Barría/Reuters)
Una guerra, nonostante il coraggioso e instancabile lavoro di figure come quelle del freelance, del fixer e dello stringer, non è mai chiara e trasparente, non lo è per definizione e nemmeno non può esserlo. Da qui però non deve emergere la necessità di lasciare scorrere gli eventi senza la copertura informativa necessaria a renderci conto di cosa stia accadendo più o meno vicino a noi, anzi. Proprio grazie a queste persone, uomini e donne che condividono con i soggetti presenti sul territorio devastato dai conflitti, non solo le storie e i drammi personali ma le condizioni di vita, le privazioni e i rischi, riusciamo a vedere e quindi a sentire ciò che accade.
Non si tratta ovviamente di un’editoria indipendente tout court, esistono i grandi gruppi broadcast che mediano, che filtrano, che scelgono, ma esistono anche in questo caso delle vie di fuga come è il caso, per esempio di alcuni Social Network (in Ucraina è oramai chiaro il ruolo centrale di TikTok), di alcuni strumenti Web (l’importanza di Telegram) e di alcune piattaforme che eliminano l’intermediazione come i Podcast (segnalo solo a titolo esemplificativo il lavoro di Cecilia Sala con il suo Stories).
Risulta evidente da questa breve analisi dei ruoli coinvolti sul campo nella produzione editoriale relativa soprattutto a eventi bellici che il concetto classico di editoria indipendente ne esce ancora più evidentemente superato. È il concetto stesso di editoria indipendente che necessita di una profonda rivisitazione alla luce di questi nuovi strumenti e di questi nuovi ruoli sempre più centrali negli scenari di guerra e non solo.
Potremmo quindi azzardare che il concetto di indipendente torna a farsi denso di significato e che il suo peso specifico riprende (ahimè) forza proprio a causa dei tristi avvenimenti di cui tutti siamo testimoni in questi giorni, eventi che sottolineano una volta di più quanto necessaria sia la libertà dell’esercizio della comunicazione editoriale e quanto ci fossimo adagiati nella nostra comoda situazione pensando che indipendente significasse oramai il solo chiamarsi fuori da certi circuiti mainstream di produzione e distribuzione di prodotti editoriali. Ecco che, proprio in questo rinnovato panorama, torna ad essere di nuovo centrale la forza dei contenuti e il loro impatto diretto sul nostro modo di vivere.
Adesso capiamo forse quanto la libertà con cui circolano le informazioni sia decisiva e con essa, il significato più classico di editoria indipendente.

(foto Canva)

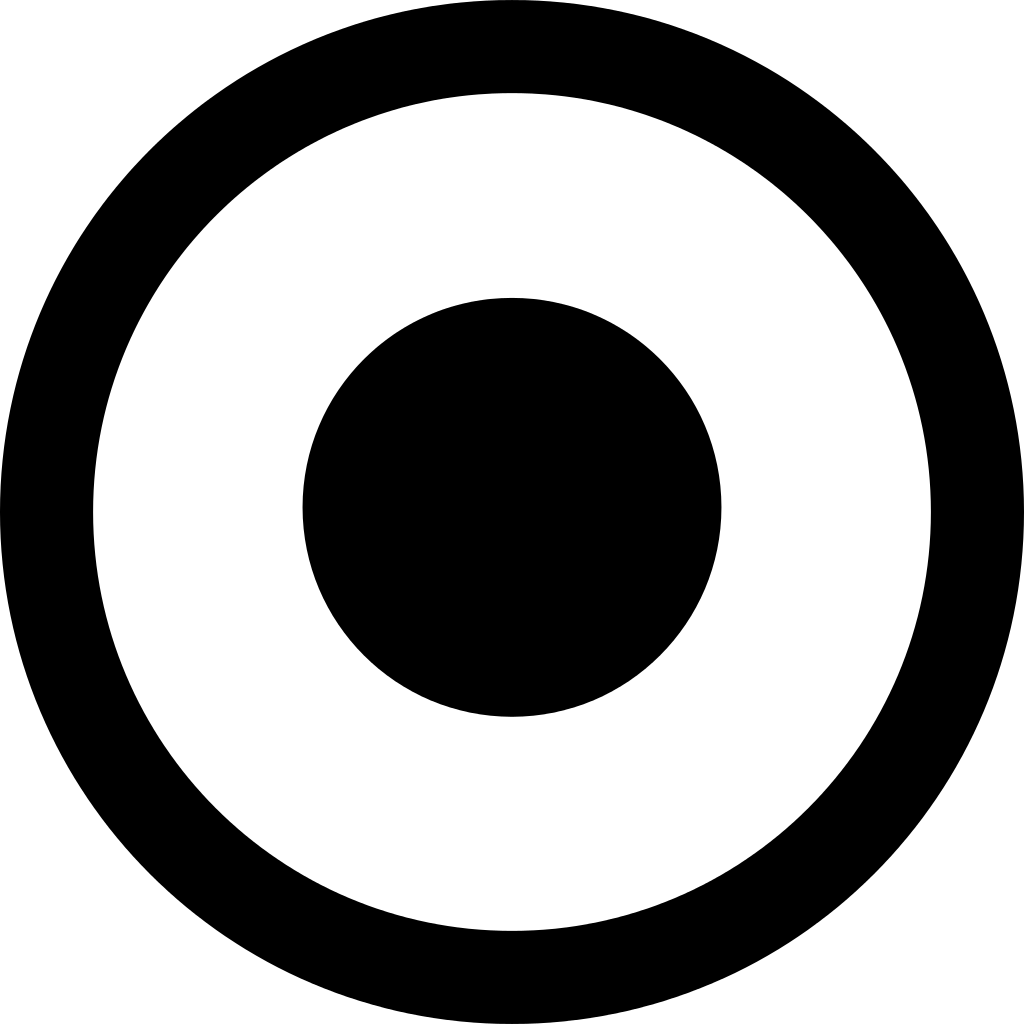 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP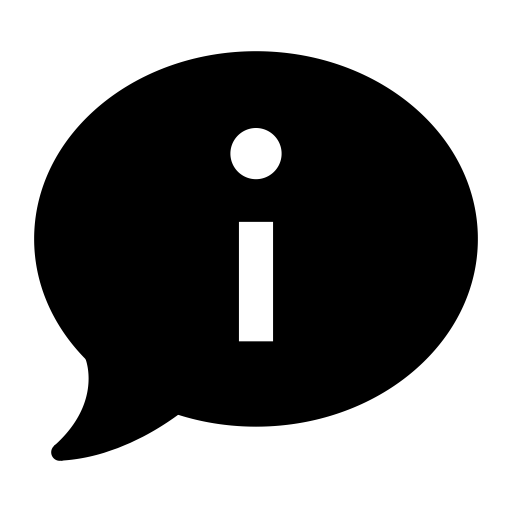 ABOUT
ABOUT 