Nel 1979, durante le riprese di una trasmissione della BBC, un tecnico del suono decise per gioco di commentare a bassa voce ciò che stava succedendo in studio, mentre un conduttore insolitamente rigido tentava di mantenere il controllo della diretta. La storia racconta che, nella sala regia, il produttore scoppiò a ridere sentendo quella voce abusiva infilarsi tra le pieghe del protocollo televisivo. Non andò mai in onda, certo, ma in quel minuscolo cortocircuito stava già germogliando l’idea della voce fuori campo come frizione, come irruzione dell’imprevisto nell’ordine prestabilito del linguaggio televisivo. Una voce che non si vede, e proprio per questo diventa più forte, più affilata, più libera.

Nieves González
Da lì, la storia di questo stratagemma comunicativo si allarga in molte direzioni, quasi come un fiume che, invece di scendere dritto, continui a ramificarsi. Negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti del boom mediatico, la voice-over nacque come strumento di autorevolezza: pensiamo a Walter Cronkite, ai documentari educativi della CBS, ai cinegiornali che avevano bisogno di una voce-guida capace di trasformare la realtà in narrazione ordinata. Era la voce del potere paternalistico, una voce che spiegava il mondo come se il mondo fosse un mobile Ikea con istruzioni chiare e semplici. Il sociologo Harold Lasswell avrebbe letto tutto questo come la forma perfetta del modello trasmissivo: un emittente forte, un messaggio limpido, un ricevente passivo, la voce come strumento di sincronizzazione emotiva della massa. Poi arrivarono gli anni Settanta e la televisione europea iniziò a giocare con la voce fuori campo come contrappunto ironico. In Francia, Antoine de Caunes e l’équipe di Rapido sperimentarono una narrazione che non commentava semplicemente le immagini, ma le contraddiceva. In Gran Bretagna, il Monty Python’s Flying Circus infilava voci che sembravano provenire da luoghi sconosciuti, fuori dal quadro, fuori dal racconto. Era la voce che rompeva la quarta parete senza bisogno di apparire, come se fosse l’eco di un narratore clandestino nascosto dietro una tenda. Qui entrano in gioco le teorie di Raymond Williams: la televisione non è solo ciò che mostra, ma ciò che scorre. La voce fuori campo diventa corrente sotterranea, una specie di “flow” che modula la percezione dello spettatore, creandogli un secondo paesaggio mentale.

Nieves González
E poi, certo, l’Italia, e qui il discorso diventa quasi antropologico perché con la Gialappa’s Band, a partire da quel 1986 di Mai Dire Banzai, la voce fuori campo smette di essere un accessorio e diventa il protagonista invisibile. La trovata geniale è che la voce non si limita a narrare, ma anzi, giudica, distorce, a spesso deraglia. È la voce del bar all’angolo, il brusio ironico di una cultura che non crede più nella solennità dello schermo televisivo. La Gialappa’s prende un format giapponese e lo capovolge: lo spettacolo non è più quello che accade sullo schermo, ma quello che le voci ne fanno e che tu non vedi. È quello che Umberto Eco chiamerebbe “iper-interpretazione umoristica”: la voce off come dispositivo di straniamento, come lente deformante che invita lo spettatore a non fidarsi mai del testo ufficiale. In altri luoghi del mondo, nello stesso periodo, succedeva qualcosa di analogo: Mystery Science Theater 3000 negli Stati Uniti, con il suo commento ironico ai vecchi film di serie B; Clive James on Television nel Regno Unito, con quella voce lucida e tagliente che svelava l’assurdo del palinsesto. Tutte forme in cui la voce fuori campo diventa coscienza critica, strumento metatestuale, vera protagonista della costruzione del significato. Secondo le teorie di Stuart Hall, qui la comunicazione non è più unidirezionale: la voce off suggerisce una lettura oppositional, spinge lo spettatore a decodificare il messaggio a modo proprio, a non accettare la versione ufficiale.

Nieves González
Con gli anni Duemila, la voce fuori campo attraversa un’altra mutazione. Nelle docu-serie, da Planet Earth fino ai prodotti più recenti di Netflix, ritorna come strumento di immersione e meraviglia; nei talent show come MasterChef diventa un bisturi narrativo; nelle serie comedy, da Arrested Development a Modern Family, assume il ruolo di narratore ironico, colui che tiene insieme brandelli di racconto e al tempo stesso li scompone. È un’ombra parlante che accompagna lo spettatore ricordandogli che ogni immagine, anche la più solida, è un artificio. E allora, più che una tecnica narrativa, la voce fuori campo diventa un vero indizio sociologico, il sintomo di qualcosa che riguarda noi più che la televisione. Perché — ed è qui che la questione si fa spinosa — la voce off non parla alle immagini: parla alla nostra fiducia. O meglio, alla nostra mancanza di fiducia. Nella sua natura invisibile si nasconde un paradosso perfetto: un medium che sottrae il corpo del parlante per moltiplicarne l’autorità, o per distruggerla. Una prima tesi, volutamente scomoda, è che la voce fuori campo non è mai davvero “fuori”: che abiti cioè il medesimo spazio simbolico delle immagini, ma ne rappresenti l’inconscio. Usata in modo istituzionale — i documentari, i reportage, i programmi pedagogici — funziona come ciò che Niklas Luhmann chiamerebbe un dispositivo di “riduzione della complessità”: la voce è lì per dirci che il mondo è interpretabile, che l’immagine non basta, che serve un garante. È una sorta di “stampella epistemologica” che ci consente di credere nel racconto. Ma quando la voce assume invece la funzione ironica, corrosiva, straniante (come nel caso della Gialappa’s o delle forme satiriche anglosassoni), allora opera in direzione opposta: non riduce la complessità, la espone e la amplifica. La voce diventa il “fantasma” che incrina la fiducia nella scena ufficiale, il tarlo che ricorda allo spettatore che la televisione non è mai neutra, che ogni frame è un artificio.

Nieves González
La seconda tesi, più radicale, è che la voce fuori campo non è semplicemente un commento: è la materializzazione dei “buchi neri” del sistema mediale. È ciò che parla quando il medium non sa più come spiegarsi. Potremmo dire che la voice-over agisce come un protocollo di emergenza del racconto: interviene dove l’immagine rischia il collasso. Funziona sia nelle situazioni di overdose visiva (talent show, montaggi frenetici, reality) sia in quelle di rarefazione sensoriale (assurdo non-sense, documentari e reportage naturalistici).
La terza tesi — la più sperimentale — è che la voce fuori campo sia l’embrione di un nuovo tipo di spettatore: lo spettatore a due livelli. Uno che guarda e, contemporaneamente, ascolta un commento che gli insegna a guardare. La voice-over, in questa prospettiva, abitua il pubblico a non fermarsi all’immagine, a percepire ogni sequenza come un dispositivo, ogni narrazione come un ingranaggio. È un addestramento silenzioso ed è per questo che la voce fuori campo è uno dei più efficaci anticorpi della contemporaneità ipermediata: crea spettatori meno docili, più mobili, più sospettosi. Paradossalmente, più liberi. E così la voce che non si vede diventa la più visibile di tutte: quella che rivela i fili, quella che sussurra che dietro ogni immagine c’è sempre un gesto, una scelta, un’intenzione. Ed è proprio in questa torsione — invisibile ma decisiva — che la televisione mostra la sua natura più autentica: non un semplice teatro di figure, ma un dialogo continuo fra mondo e sguardo, fra scena e coscienza, fra ciò che appare e ciò che, finalmente, qualcuno ha il coraggio di dire.

Nieves González

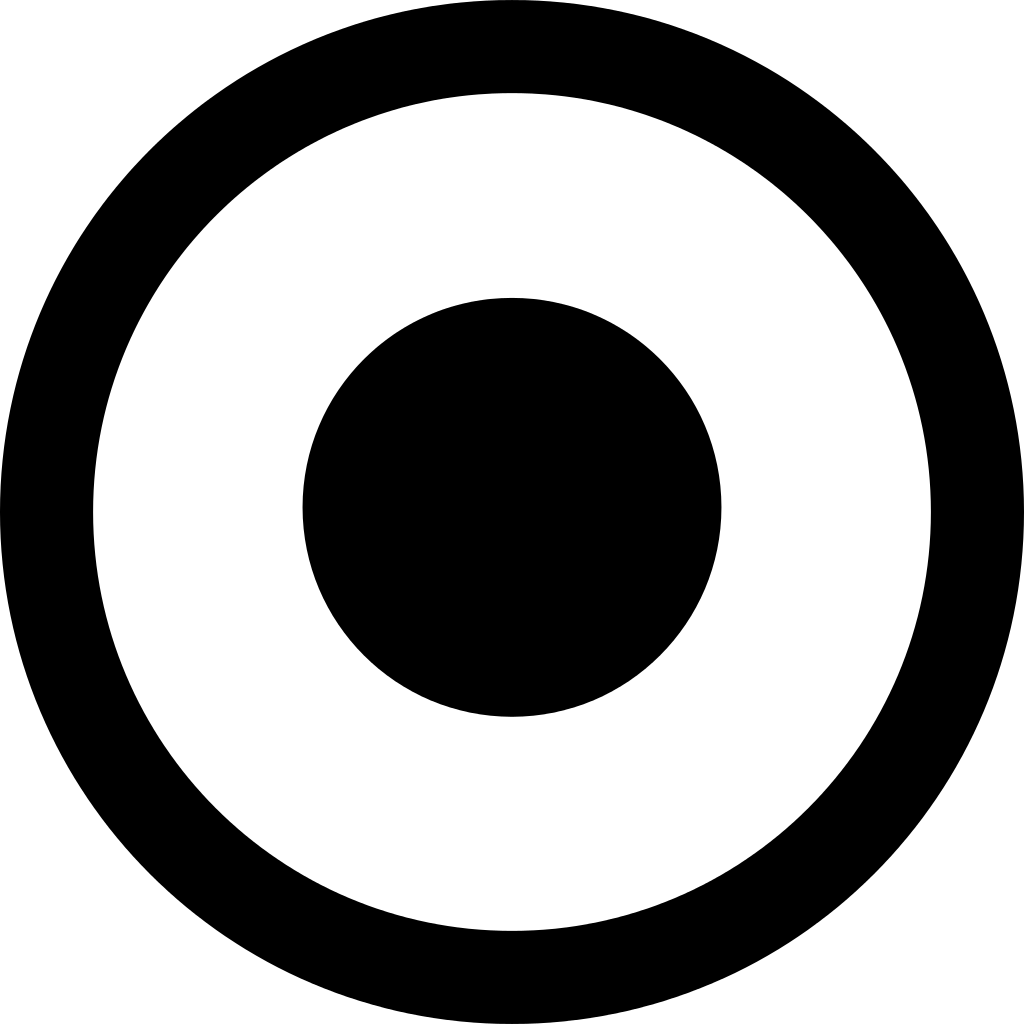 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP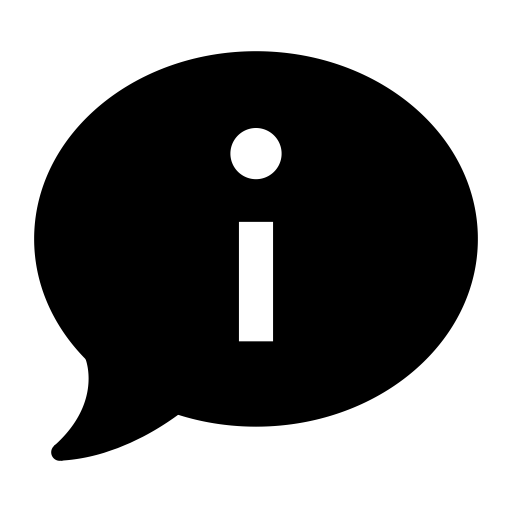 ABOUT
ABOUT 