Nei sobborghi di Minneapolis, da tempo segnati da profonde tensioni sociali e da un clima di sfiducia verso le autorità, sono tornati con ancora più forza al centro dell’attenzione gli abusi di potere delle forze di polizia.
A partire da gennaio 2026, la città è diventata l’epicentro dell’Operazione Metro Surge, una campagna del Dipartimento per la Sicurezza Interna che ha portato all’impiego di circa duemila agenti e a migliaia di arresti, spesso accompagnati da violenze e uccisioni, come quelle di Renee Nicole Good e Alex Pretti.
La risposta della popolazione civile non si è fatta attendere: in tutto il territorio si è formata una rete di cittadini chiamata copwatchers, persone comuni che sorvegliano le attività della polizia e dell’ICE, registrando ogni intervento con smartphone e telecamere montate sulle auto.
Attraverso chat Telegram, gruppi protetti e sistemi di tracciamento legale, questi vigilanti civili organizzano una vera e propria “contro-sorveglianza”, costruendo una mappa in tempo reale delle operazioni di polizia.
Il copwatching non è solo un atto politico, ma anche una forma di creatività visiva.
I video prodotti dai copwatchers hanno un’estetica inconfondibile, lo-fi, fatta di immagini tremolanti, rumore visivo, sfocature e inquadrature instabili. Tutto ciò che nel linguaggio televisivo o cinematografico tradizionale verrebbe considerato errore — una ripresa mossa, una luce bruciata, un suono distorto — diventa invece il marchio di autenticità di chi filma. L’immagine sporca, imperfetta, frammentata, rivela che chi sta dietro la fotocamera è presente nel momento del pericolo, coinvolto fisicamente e moralmente nella scena. Non si tratta di una visione esterna né neutrale, è la prova incarnata di un testimone che partecipa, che rischia, che mostra ciò che il potere vorrebbe tenere nascosto. Questa estetica, che rifiuta la perfezione levigata delle immagini istituzionali e delle bodycam ufficiali, diventa una dichiarazione ideologica:
la verità non è nella chiarezza apparente,
ma nella tensione dell’istante,
nella crudezza della testimonianza
La cultura visiva dei copwatchers si colloca dentro una genealogia lunga e profonda della resistenza visiva americana. Le loro radici affondano nelle ronde armate del Black Panther Party negli anni Sessanta, che pattugliavano le strade per difendere le comunità nere dagli abusi, e nei Deacons for Defense, che proteggevano i propri quartieri nel Sud segregazionista. Negli anni Novanta, dopo l’uccisione di Rodney King, i gruppi di Copwatch a Berkeley e altrove istituzionalizzarono la ripresa video come strumento di difesa collettiva. La lezione di quelle esperienze si è trasformata, oggi la telecamera è una nuova forma di scudo, e il flash dello smartphone è una luce che smaschera il potere invece di nasconderlo.
Giubbotti riflettenti, occhiali modificati con piccole torce, braccialetti con QR code e cartelli plastificati sono diventati i nuovi simboli visivi di una presenza civile che vuole essere riconosciuta, ma non dominata.
In questa iconografia della resistenza la visibilità non è più una condanna,
ma una rivendicazione.
Il linguaggio visivo dei copwatchers continua e rinnova la tradizione della cultura underground americana, quella che dagli anni Sessanta a oggi ha sempre cercato di opporsi al potere attraverso forme espressive alternative. Se i collettivi punk degli anni Ottanta filmavano in Super 8 concerti e scontri con la polizia per denunciare la brutalità e affermare la propria autonomia, oggi i copwatchers usano i mezzi digitali per un obiettivo analogo: trasformare la precarietà tecnica in forza etica.
La bassa qualità diventa così una forma di purificazione, un rifiuto consapevole dell’apparenza spettacolare dei media mainstream. Riprendere significa esistere, testimoniare e resistere al tempo stesso. Ogni fotogramma sgranato è una ferita, ma anche una prova di presenza e verità.
Questa estetica rappresenta una rivoluzione dello sguardo. Come ha teorizzato Michel Foucault nel descrivere il panopticon, il potere moderno si fonda sul controllo invisibile: si viene osservati, ma non si può guardare chi osserva. Il copwatching ribalta questo schema, restituendo alla cittadinanza il diritto di scrutare l’autorità. L’obiettivo dello smartphone diventa uno strumento di democratizzazione dello sguardo, un gesto politico che toglie all’istituzione il monopolio della verità visiva. Proprio qui si inserisce anche il pensiero di Jacques Rancière, secondo cui la politica dell’immagine consiste nel ridefinire chi ha diritto di apparire, di essere visto e di prendere parola. I copwatchers rompono questa “ripartizione del sensibile”, non accettano che solo i poteri ufficiali possano raccontare i fatti. Ogni video amatoriale è un atto di redistribuzione della percezione, una piccola rivoluzione democratica che ribadisce che anche chi è ai margini ha diritto non solo a parlare, ma a mostrare.
La filosofia estetica del copwatching si fonda sul corpo e sulla presenza. Filmare da vicino, tremando, respirando, urlando, non è semplice documentazione, ma partecipazione: la camera diventa un prolungamento della propria vulnerabilità. È una forma di arte politica incarnata, dove il gesto tecnico diventa un atto etico. Seguendo l’intuizione del regista cubano Julio García Espinosa, che sosteneva che il cinema degli oppressi deve abbandonare la pulizia formale per essere davvero libero, i copwatchers fanno della bruttezza un’arma estetica e morale. La loro immagine non abbellisce, non distorce, non nasconde: mostra la verità attraverso l’imperfezione.
Questa forma di visione non nasce nel vuoto, ma appartiene a una cultura sotterranea che da decenni esplora i margini tra arte e attivismo. Dai No Muos siciliani che trasmettono video sgranati delle loro proteste, ai livestream zapatisti dal Chiapas, fino ai collettivi europei che filmavano le rivolte con videocamere portatili, ogni gesto di filmare dal basso afferma una nuova possibilità di democrazia. È la continuazione della cultura underground, quella che rifiuta la perfezione per difendere la verità, che non cerca consenso ma coscienza.
Oggi questa tradizione sopravvive e si rinnova con i copwatchers, che fanno della visione una nuova forma di disobbedienza civile. Mostrare diventa un atto di giustizia, e la telecamera uno strumento di libertà. Nell’epoca della sorveglianza totale, dove tutto è registrato ma poco è realmente visibile, la loro estetica imperfetta indica la strada di un’altra verità: quella che nasce dal basso, che non ha paura di tremare, e che proprio per questo riesce a restituire il volto umano della resistenza.
Così, tra le strade illuminate dalle luci blu delle sirene e dai riflessi metallici degli smartphone, si riscrive la storia della cultura visuale contemporanea: non più un’arte per pochi, ma una democrazia dello sguardo, dove filmare significa opporsi, e guardare diventa un atto di libertà.

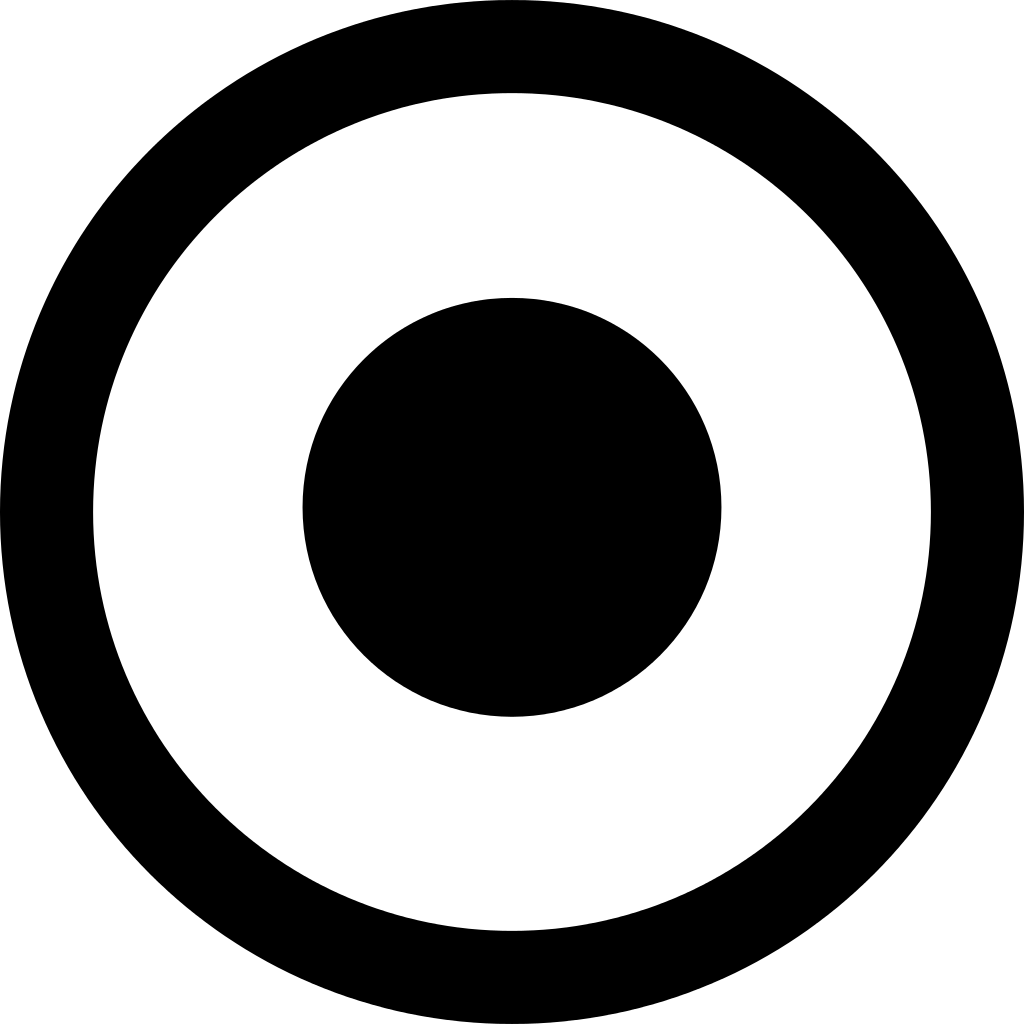 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP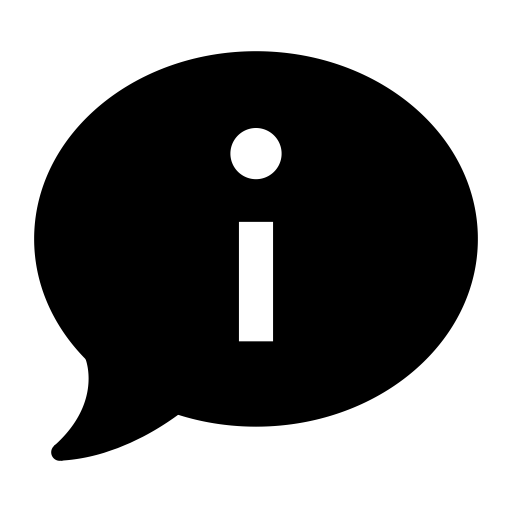 ABOUT
ABOUT 