Continua il nostro approfondimento con DISPACCI, una serie di conversazioni con alcuni inviati italiani che si trovano sul fronte del conflitto ucraino.
Oggi parliamo con Lorenzo Cremonesi, giornalista nato a Milano nel 1957 che segue da oltre 25 anni le vicende mediorientali ed in generale le zone di conflitto. Cremonesi è stato dal 1984 collaboratore e dal 1988 fino al 2001 corrispondente da Gerusalemme per il Corriere della Sera.
Dai primi anni Novanta ha iniziato a muoversi anche come inviato, dando voce a molti punti caldi del pianeta come Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan. Cremonesi è inoltre autore di numerosi libri sul conflitto israelo-palestinese.

Lorenzo Cremonesi inviato da Kiev
Siamo alla vigila della Pasqua e, con mia moglie, abbiamo invitato a mangiare la pizza da noi, un’amica Ucraina con la sua famiglia. Si tratta di amici che vivono qua da anni e i cui figli passano molto tempo con i nostri. In totale siamo undici persone a tavola e quando squilla il telefono e vedo che a chiamarmi è Lorenzo Cremonesi scappo nel mio studio evitando in modo maleducato di salutare. Erano giorni che tentavo di organizzare questa chiacchierata e non potevo non approfittare. Mi precipito quindi a rispondere perché so bene che potrebbe essere una delle poche possibilità che mi viene data visto che Cremonesi si trova in Ucraina come corrispondente per il Corriere della Sera.
Non mi dilungherò oltre sui problemi del collegamento che mi vede utilizzare molti dei canali che oggi ci permettono di restare connessi: prima Whatsapp, poi Messenger, infine la classica linea telefonica.
Lorenzo mi dice che è il momento giusto perché ha una pausa dovuta al suo spostamento da Kiev a Mariupol ed io capisco che è il momento per approfittarne e chiudo tutti fuori dal mio ufficio casalingo e ascolto le risposte che Lorenzo da alle mie domande.
Ciao Lorenzo,
Per prima cosa desidero davvero ringraziarti per aver accettato la mia intervista.
La prima domanda che vorrei farti riguarda il concetto di vocazione, termine che deriva dal latino vocatiònem, ovvero essere chiamato, e che sostanzialmente rimanda ad una sorta di chiamata interiore per il quale qualcuno si sente portato ad operare per il bene comune. Quella del mestiere di inviato nelle zone di guerra può essere definita come una vocazione? Perché si o perché no?
Su questo tema c’è tanto materiale, tra l’altro tra meno di un mese esce il mio nuovo libro che si intitola Guerra infinita e che tratta proprio di questo. Io direi che l’inviato che va in zona di guerra si costruisce piano piano, non è che venga folgorato sulla via di Damasco. Prima di tutto perché noi europei, occidentali, cresciuti nelle generazioni successive alla Seconda Guerra Mondiale, almeno in Europa, la guerra non l’abbiamo davvero mai conosciuta o comunque non la conosciamo per come davvero si manifesta, la conosciamo sui libri, dai racconti dei nostri nonni o dei nostri genitori.
La guerra è un evento totalizzante. Quando qualcuno comincia a lavorarci capisce in breve tempo se è tagliato o no per questo tipo di mestiere. La gente è totalmente coinvolta dal conflitto e capisce che in certi contesti si prendono decisioni in tempi brevi, anzi brevissimi. La guerra ti obbliga a farlo, non hai molta scelta e quindi o ci si appassiona o ci si spaventa.
Io quando comincio a seguire un conflitto, voglio sapere come finisce e mi ritrovo ad essere coinvolto pienamente dalle dinamiche che vado raccontando. Poi esistono conflitti che a prima vista ci appaiono estranei.
Per certi versi si potrebbe anche dire che io sia qui come cittadino prima ancora che come inviato, proprio perché la guerra ha la capacità di coinvolgerti e quindi, per rispondere alla tua domanda, per quanto mi riguarda la vocazione nasce dall’essere dentro la storia del conflitto e viverla direttamente in prima persona.
Un aspetto non sempre sottolineato del mestiere di inviato nei fronti più caldi del pianeta ritengo sia nel suo farsi occhi, nel trasformarsi cioè in testimone, molto spesso inerme, di tragicità e violenze. Qual’è a tuo avviso lo scopo ultimo del tuo lavoro e quali gli errori che proprio non si devono commettere per offrire un corretto servizio pubblico?
Lo scopo è cercare di trasmettere a chi mi segue l’immediatezza di ciò che vedo con la massima onestà possibile e consapevole della presenza ovunque della propaganda. Su questo, sarà pure banale ripeterlo, ma è proprio vero che la prima vittima della guerra è e sarà sempre la verità. Quando si è in condizioni estreme infatti, siamo tutti portati a mentire. Se per esempio si è su un autobus che cade in un dirupo, chi sopravvive e vede le vittime, tenderà a ingigantire il fatto, a dire cioè che sono tutti morti. L’uomo esagera quando è posto in condizioni di forte stress emotivo e in guerra questo stato di cose è perdurante e estremo.
Il primo problema è quello di riuscire a trasmettere questo stato di cose tentando, se possibile, di rimanere fedeli alla propria narrazione e quindi di non contraddirsi.
Quando per esempio sono arrivato a Kharkiv, esattamente di fronte al Municipio in Piazza della Libertà che è stato bombardato pesantemente divenendo una delle innumerevoli immagini iconiche di questo conflitto, una delle prime situazioni su cui tutti i giornalisti ci siamo concentrati è stato un missile che era conficcato nel terreno, come un qualsiasi ordigno inesploso. L’immagine, capirete, era davvero molto forte, ottimo soggetto per le foto, con il perfetto mix di drammaticità e iconografia. Il giorno dopo però, torno sul luogo e scopro, parlando con qualche residente, che si trattava di un monumento storico della piazza, eretto anni prima per ricordare al popolo ucraino la crudeltà dell’esercito russo.
Essere consapevole che quello che vedi oggi non è una verità incisa sulla pietra e quindi che non vale per sempre, ci dimostra come, soprattutto in guerra, tutti noi siamo costantemente vittime della contingenza.
Apprezzo davvero l’inviato che si dimostra in grado di cambiare le proprie idee con cui è arrivato sul posto. Non mi importa niente se questo rischia di confondere il lettore, l’errore vero di ogni inviato è quello di arrivare con una tesi e rimanere vincolato ad essa anche quando ciò che vede lo dovrebbe portare a fare altre considerazioni. Il bravo inviato cambia idea.

Municipio di Kharkiv, 18 marzo 2022. Il Manifesto
Dietro ad ogni cinepresa, ad ogni macchina fotografica e ad ogni smartphone esiste comunque una persona, con una propria storia e una propria sensibilità. Cosa succede ad un essere umano quando si trova inserito in un contesto fatto di violenza e morte e, per sua scelta, deve testimoniare nel modo più obiettivo possibile tali accadimenti? Quali sono le sensazioni umane che lo attraversano e soprattutto come è possibile non rispondere alla domanda, credo legittima e del tutto umana, di fermarsi e dare libero sfogo ai sentimenti?
Io oramai sono 40 anni che faccio questo mestiere quindi, non dico di essere diventato cinico, ma ovviamente non sono più lo stesso di venticinque anni fa.
Ti racconto una storia che credo possa essere utile alla nostra chiacchierata. Nel 2003 mi trovavo a Baghdad durante la seconda Guerra del Golfo che più o meno ebbe una durata di circa venti giorni. Dopo dieci dal mio arrivo alcuni iracheni che stavano con noi ci portano vicino ad un ponte che era stato bombardato da pochissimo da un missile americano. A ridosso della struttura oramai completamente distrutta, ci trovammo di fronte ad una madre gravemente ferita, messa davvero male, e con lei, i suoi due gemellini di alcuni mesi. I pochi medici sul posto tentarono di utilizzare il sangue della madre del medesimo gruppo sanguigno, per salvare i bimbi e questo portò l’espressione della donna verso un quasi sollievo mentre, la realtà era ben diversa e infatti, in pochi minuti, ci ritrovammo di fronte ai cadaveri di tutti e tre. Ovviamente una scena del genere, a me giovane inviato, colpì profondamente ma, negli anni ho capito che un bravo inviato deve per lo meno tentare di dare l’impressione del dramma in corso, della ferocia degli eventi e della disumanità a cui si assiste, ma sapendo sempre che noi non siamo medici.
Io, per esempio, non do mai soldi, non fornisco mai informazioni su di me o sui miei recapiti. Io arrivo sul posto e so benissimo che quello che ho con me potrebbe salvare la vita a molte persone. Pensate al telefono satellitare, ai soldi, alla benzina, alla macchina e a tutto ciò che utilizziamo noi più o meno normalmente nel nostro lavoro sul campo. So però benissimo anche che è necessario il dovuto distacco, la giusta freddezza.
Io, come inviato, devo restituire al lettore la dimensione strategica derivante da quello che vedo, devo estraniarmi il più possibile da ciò che mi accade davanti agli occhi perché il mio compito è andare oltre la sofferenza e distinguere le parole e i fatti tramite la ragione e la razionalità del cronista di guerra.
Anche qua credo sia utile un esempio. In ogni guerra che ho raccontato, sempre, si accusa il nemico di violenza sulle donne. È una regola generale che ho notato, ma non è davvero così, almeno non sempre. Nella Guerra dei Balcani, nello specifico nella ex Jugoslavia, quella era una deliberata scelta politica, la violenza sulle donne era appunto una scelta deliberata e onnipresente mentre qua in Ucraina, per quanto mi è dato di conoscere, i russi non hanno davvero portato avanti questo tipo di violenza,
La vera storia è nei dettagli e nel lavoro che si deve fare per cercare di portarne a galla il maggior numero possibile, poter quindi essere in grado di costruire una narrazione del conflitto il più aderente possibile a ciò che consideriamo la verità.
A questo proposito possiamo riprendere la famosa citazione contenuta nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito di Hegel in cui il filosofo tedesco racconta della “notte nera dove tutte le vacche sono nere”, quando cioè tutto appare indistinto e quel che è peggio indistinguibile. Tutto uguale, nessuna differenza.
Se analizziamo la figura del giornalista indipendente, soprattutto da un’ottica storica, risulta un più o meno costante il rifiuto delle logiche commerciali. L’editoria, e in generale la comunicazione indipendente, preferisce infatti solitamente il concetto di libertà di espressione rispetto a quello di remunerazione economica. Pensi che anche oggi si possa parlare di forme di comunicazione indipendente e, se pensiamo allo specifico contesto del conflitto in Ucraina, ritieni esista davvero la possibilità di fornire un’informazione libera e indipendente? Perché?
Io sono nato nel 1957 e il mio periodo formativo principale è stato quello universitario, figlio di quel Sessantotto che io rivendico come una fase fondamentale nella mia crescita personale, oltre che professionale. Certo, oggi sono molto critico con ciò che avvenne allora, ma un aspetto rimane ancora oggi, a mio avviso, estremamente importante di quel periodo storico ovvero che il Re è nudo. Quello che voglio dirti è che c’è un’informazione di Stato che si alimenta degli interessi dello Stato stesso. Io provengo da quella stagione in cui questa consapevolezza si è fatta centrale nel mestiere di chi deve raccontare i fatti di cui è testimone diretto.
Noi giovani al tempo eravamo quasi tutti schierati e quello possiamo definirlo come l’errore dell’ideologia che portò al dogma contro dogma, ma questo approccio critico mi ha portato comunque a mettere sempre tutto in discussione, ad avere dubbi e non certezze, a pormi domande su domande.
Detto questo, la narrativa di guerra non scaturisce esclusivamente dalla testata giornalistica. Quella che è la salvezza dell’informazione viene invece dal fatto che esista una pluralità di narrazioni e se quindi io ho la possibilità di ricercare su più fonti diverse, alla fine credo sia meno difficile riuscire a crearmi una mia idea dei fatti.
Personalmente posso dire di essere stato abbastanza libero nella mia carriera di giornalista pur nella consapevolezza che non sono io in definitiva a fare il giornale e che quindi esistono tutta una serie di altri elementi che contribuiscono alla linea editoriale. Diciamo che rappresento una rotella, un ingranaggio di una macchina più grande e quindi più complessa.

Un civile si allena per lanciare bottiglie molotov per difendere la città, a Zhytomyr, Ucraina, 1 marzo 2022. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Quella del freelance è una figura che per molti aspetti si distanzia dal classico inviato delle media companies. Quali sono a tuo avviso le principali differenze fra i due ruoli e quali gli aspetti positivi e negativi di entrambi?
Le differenze fra freelance e inviati delle testate sono gigantesche e, a mio avviso, rappresentano lo specchio del decadimento con cui viene visto il ruolo del giornalista.
Io sono, per capirci, un’inviato con uno stipendio, un’assicurazione, una pensione e delle tutele legali.
Quando ho iniziato, anche io ero freelance ma la situazione era profondamente differente. Al tempo venivo pagato un sacco di soldi per i miei pezzi perché eravamo in pochi disposti a farlo e gli strumenti erano quelli che erano. Oggi invece, i freelance vengono pagati pochissimo, una vergogna si potrebbe dire. Sono sfruttati e sottopagati e questo porta a delle dinamiche – su cui io sono da sempre molto critico – che vede i freelance non solo come figure di sfruttati ma anche di figli di papà e su questo cerco di spiegarmi meglio per evitare fraintendimenti. Questi giovani sul campo innanzi tutto rischiano moltissimo in prima persona e senza avere nessuna testata che davvero gli copra le spalle, ma a peggiorare la situazione c’è anche il fatto che non tutti si possono sostenere l’auto finanziamento delle proprie missioni e dei propri viaggi, di acquistare le strumentazioni necessarie etc. Questo modo di fare giornalismo è cinico e sbagliato e porta al triste risultato che oggi essere freelance è diventato un lavoro solo per coloro i quali possono permetterselo e questo non è giusto né per i freelance, né per il mestiere del giornalista.
Il linguista Raffaele Simone ha scritto che «guardare è più facile che leggere» e quindi dobbiamo abituarci all’idea che si affermino nuovi stili conoscitivi, fondati sulla simultaneità e sull’iconicità, dove la visione delle immagini diventa la fonte primaria per acquisire conoscenze. Ritieni che davvero oggi il linguaggio visuale, le immagini, i video e le stories, siano il fulcro della comunicazione o, alla fine, è ancora il testo che riesce a veicolare contenuti nel miglior modo possibile?
Le rispondo con una parabola che a prima vista può apparire snob ma non lo è.
Il testo scritto è elitario mentre le immagini sono alla portata di tutti.
Quando nel 1991 mi trovavo a Tel Aviv, in Israele, dove arrivavano i missili SCUD lanciati da Saddam Hussein dall’Iraq, avevo circa trent’anni e già da nove ero inviato del Corriere della Sera. Questi SCUD erano ordigni di fabbricazione russa, vecchi e non affidabili, e si distruggevano molto spesso durante il volo. Per gli iracheni questi lanci disperati appresentavano il tentativo di dividere la coalizione alleata guidata dagli Stati Uniti di concerto con molte altre forze occidentali. Uno di questi missili colpì una casa alla periferie della città israeliana portando alla morte di tre persone di cui un’anziana che non era in grado di muoversi e quindi si era rifugiata nella sua abitazione. I giornalisti subito accorsi per raccontare e fotografare l’accaduto, si trovarono di fronte una scena molto meno cruenta del previsto, con i ristoranti della zona tutti aperti e pieni di persone tranquillamente sedute a mangiare, altri addirittura erano in spiaggia a fare il bagno, insomma una relativa normalità quotidiana che mi fece dire al mio giornale che quella non era una vera storia, che non c’era quindi niente da raccontare.
Molti colleghi utilizzarono le immagini dell’appartamento, dei cadaveri e dei feriti, per descrivere un evento cruento e questo semplice esempio credo ti faccia capire come spesso, molto spesso, le immagini ti fanno vedere ciò tu devi vedere mentre, al contrario, la parola è in grado molto meglio e a fondo di spiegare il quadro complessivo, con più dettagli e possibilità di approfondimento e, nel migliore dei casi, di favorire una riflessione.
Quale ritieni siano i principali problemi e limitazioni a cui è soggetta la figura di reporter nell’attuale panorama dell’informazione in Italia e quali pensi siano le principali differenze fra la realtà italiana e quella internazionale?
I problemi sono molti e molto vari, non solo per la realtà italiana, ma anche e soprattutto per quella internazionale.
Oggi si chiede agli inviati di inviare aggiornamenti ogni due minuti, senza apparente motivazione e senza sosta. Sembra che ci sia bisogno di un flusso informativo costante, ma questo rappresenta il limite del lavoro del reporter ovvero la mancanza di approfondimento. Se io devo scrivere e raccontare, credo sia ovvio che è necessario approfondire, studiare, tentare analisi ed invece questo tempo viene sacrificato in favore di una richiesta continua di pillole informative molto spesso, per forza di cose, caratterizzate da superficialità.
Da quando esistono i Social Network e con essi la perenne connessione degli utenti, non facciamo altro che guardarci, farci vedere. Ci mostriamo vicino alle bombe, vicino ai feriti, ai cadaveri, ai mezzi distrutti e io questo non lo approvo e quindi non lo faccio perché lo trovo terribile perché va a discapito della corretta informazione che, come detto, dovrebbe al contrario, fornire elementi e strumenti utili per una corretta analisi dei fatti.
In Italia poi resta il problema del sensazionalismo che porta i media a ricercare e dare spazio e voce a chiunque abbia un punto di vista differente, meglio addirittura se contrario, a quello fornito dalla maggioranza.
L’ultima domanda che vorrei porti riguarda il concetto di Post verità, ovvero l’argomentazione, caratterizzata da un forte appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione pubblica. Come pensi sia possibile che proprio in una società in cui tutto (o quasi) è documentabile e visibile da (quasi) tutti, si sia diffuso questo fenomeno e soprattutto quali pensi possano essere dei rimedi efficaci a questa pericolosa deriva delle informazioni?
Qua il problema non è solo dei media, questi fanno infatti parte di un sistema molto più ampio e complesso, dove tutti possono dare la propria versione dei fatti. Questa apparente forma di democrazia dei punti di vista porta però – e lungi da me criticare il pluralismo di cui ho già detto in precedenza – a una totale mancanza di gerarchia delle fonti e degli interlocutori, tra chi sa e chi non sa, tra chi può mettere sul piatto anni e anni di esperienza sul campo e chi invece sfrutta il momento di esposizione mediatica per costruirci su una carriera. Pensate a cosa è successo con il Covid, esattamente questo…
In rete tutti i contenuti vengono proposti allo stesso modo e questo porta a dare a tutti la stessa dignità. Siamo quindi giunti al totale appiattimento dell’esperienza e della conoscenza, ma credo che questo stato di cose sia destinato a finire.
Io poi, a diciassette anni, me ne sono andato dall’Italia vivendo spesso e per lunghi periodi in Israele ed in altre zone di conflitto quindi non sono forse la persona che più conosce la realtà attuale italiana ma credo che figure come quelle del professor Orsini che sostengono posizioni assurde non possono avere spazio solo perché differenti e contrarie dalla maggioranza. Questo porta alla confusione e alla crisi della comunicazione di massa.

Una veduta aerea mostra un edificio residenziale distrutto dai bombardamenti nell’insediamento di Borodyanka nella regione di Kiev, Ucraina, 3 marzo 2022. REUTERS/Maksim Levin
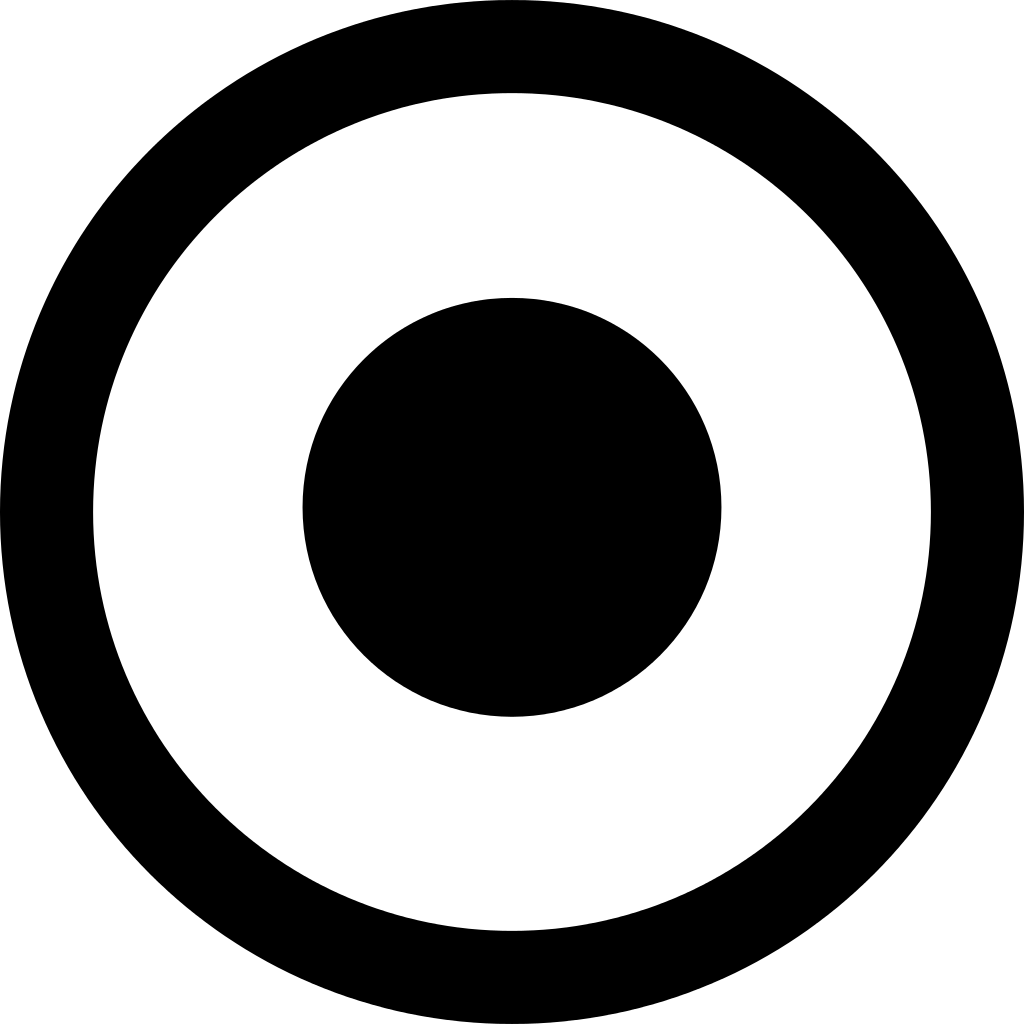 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP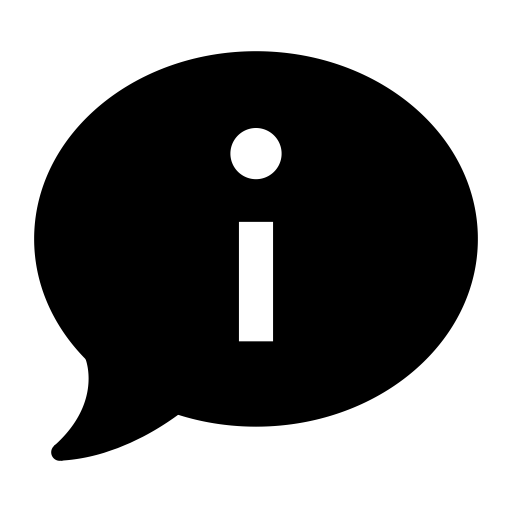 ABOUT
ABOUT 