Oggi vi presentiamo l’inviata appena tornata dall’Ucraina, Veronica Fernandes (QUA il suo profilo Instagram), giornalista della redazione di Rai News 24. Nata a Mantova ma con origini tra Goa e Kenya, dopo il liceo Scientifico ha frequentato l’Istituto IFG Carlo de Martino, una delle più importanti e prestigiose scuole di giornalismo italiane con sede a Milano.
La sua carriera di giornalista è iniziata nella sede regionale della Lombardia della Rai per poi, nel 2010, effettuare il salto da Milano a Roma, alla rete all-news della televisione pubblica, Rai News 24 dove si occupa di politica estera. Negli ultimi anni ha lavorato da Madrid, da Nuova Delhi e per due anni è rimasta in America, prima a New York e poi a Miami nel 2007. Nel 2022 ha effettuato resoconti dalla guerra in Ucraina come inviata.

Ciao Veronica,
come sempre, la prima cosa è ringraziarti per la tua disponibilità a rispondere alle mie domande.
Anche a te ne rivolgo una di quelle divenute tipiche di questa mia indagine sugli inviati nei media contemporanei, alla luce della guerra a cui stiamo assistendo. Qual’è il tuo modo di prepararti per una missione come inviata di guerra? Quali sono le emozioni e le titubanze che ti accompagnano prima della partenza e come tenti di gestirle nella tua quotidianità?
Prima di partite per ogni trasferta cerco di studiare il più possibile – leggo, guardo reportage (soprattutto BBC, Al Jazeera, CNN) e seguo su Instagram giornalisti e altre persone che fanno un racconto della quotidianità. Una cosa che mi è utile è tenere una mappa in cui segnare i cambiamenti sul campo, in Ucraina per esempio, questo è stato fondamentale. Se ci sono colleghi che ci sono già stati cerco di assorbire le loro impressioni e chiedo dritte pratiche. E poi preparo lo zaino, scelgo un libro che mi accompagnerà nelle sere in solitudine e mentalmente sono pronta.
Uno degli aspetti che ho notato durante le numerose dirette dei corrispondenti dal campo delle diverse testate giornalistiche è il sempre maggiore utilizzo di operatori freelance. Qual’è, a tuo avviso, il motivo che spinge le media companies ad adottare queste scelte e quali sono le differenze principali fra la figura dell’inviato e quella del freelance sia dal punto di vista burocratico e legale, sia soprattutto da quello dei contenuti realizzati?
Tanti giornalisti freelance sono anche amici e seguo quotidianamente il loro lavoro: intenso, spesso di lunga durata, con mesi su un territorio che permettono di avere uno sguardo e una capacità di analisi molto profonde. Mi appassiono molto al lavoro e al modo di raccontare dei singoli – o dei team – più che alle categorie.

Puoi descrivere quello che è il modus operandi di un inviato di guerra? Mi riferisco in particolare alla realizzazione dei contenuti, come si scelgono, come si realizzano e quando si capisce che il materiale è pronto per essere inviato?
Penso che non ci sia una giornata uguale alle altre. Se c’è una breaking news si segue quella – a qualsiasi ora: si interrompe quello che si sta facendo e si inizia a costruire da lì il proprio servizio. Mi è successo varie volte in Ucraina, ad esempio con l’affondamento della Moskva, ma anche in altri Paesi. Altrimenti al mattino – dopo aver visto cosa è successo nella zona in cui ti trovi e studiato le opzioni per la giornata – si decide a quale storia dedicarsi. Nei miei ultimi giorni a Mykolaiv abbiamo deciso di incontrare gli abitanti dei diversi villaggi sulla linea del fronte e ogni giorno abbiamo realizzato un piccolo reportage sulla loro vita quotidiana, breaking news permettendo. Poi diciamo che ogni dieci minuti si controllano le news perché i piani possono sempre cambiare.
Un servizio forse non è mai pronto, nel senso che lo vedo come sempre perfettibile, ma la mia prima capa mi ha insegnato che «il miglior pezzo è quello che va in onda all’orario in cui te l’ho chiesto» e quella resta per me la regola aurea. Ho applicato le stesse regole in Kenya, raccontando il Covid attraverso le diverse zone del Paese, in Usa durante le elezioni: studiare, pianificare ed essere pronti a smontare tutto.
Guy Debord nel La Società dello spettacolo scriveva che: «Lo spettatore più contempla, meno vive; più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la propria esistenza e il proprio desiderio.» Entra quindi in ballo il concetto di informazione come immagine, come spettacolarizzazione della realtà. Quanto oggi il nostro sistema di informazione è costretto a farsi spettacolo e dove credi resistano i margini per un’informazione che sappia smarcarsi da questo rischio?
Io credo che chi lavora nell’informazione debba avere come stella polare l’accuratezza e il dubbio. Per l’accuratezza intendo fare più ricerche e controlli possibile, chiedere dettagli, informazioni aggiuntive, parlare tanto con le persone coinvolte, avvicinarsi il più possibile e vedere e verificare con i propri occhi. E subito dopo viene il dubbio: farsi delle domande per capire i nostri punti ciechi, gli interessi di chi ci parla, le parti mancanti. Un buon articolo o servizio arriva alla fine, credo, di questo processo – poi ognuno aggiunge il suo modo di raccontare, di scegliere le storie, lo sguardo. Questo vale per i conflitti come per ogni altro tema.

Nel rifugio insieme ad alcuni dei 150 abitanti del villaggio che, nonostante i bombardamenti quotidiani, rifiutano di andarsene.
Quelli che sono gli strumenti tecnologici di cui disponiamo hanno portato, oltre ad una serie di passi avanti, anche alcuni punti di criticità nel mondo dell’informazione che credo sia necessario approfondire. Uno di questi riguarda il fatto che abbiamo imparato la cosiddetta lettura frammentata, quella cioè che prevede l’esposizione a un massiccio flusso di informazioni e immagini, ma stiamo perdendo la lettura profonda, cioè quella che ha bisogno di pazienza cognitiva. Possiamo semplificare dicendo che oggi siamo in grado di sapere tutto senza capire niente. Qual’è il tuo punto di vista?
A volte abbiamo tante informazioni ma ci manca la cornice. È una questione su cui rifletto molto come persona e come giornalista. Da un lato ricorro a riviste storiche – in particolare Foreign Policy o Economist – per iniziare a costruire e consolidare la cornice. E lo stesso vale per giornalisti che hanno una lunga esperienza sul campo la cui capacità di visione è enorme perché sommano analisi, fonti dirette e un vissuto verticale. Allo stesso tempo i Social Media mi aiutano molto a capire i dettagli – tornando all’Ucraina: tantissimi cittadini tengono un diario su Instagram di quello che succede a loro e intorno a loro dal primo giorno dell’invasione e per me vedere così da vicino il quotidiano di una guerra, le crepe che mostra, il cambiamento interiore cui costringe tutti è fondamentale per capirne l’impatto sulle persone e iniziare il mio percorso per raccontarlo.
Da un punto di vista storico, l’informazione indipendente nasce e si sviluppa negli anni Sessanta e Settanta quando il modo di fare informazione cambia radicalmente con il venir meno della fiducia nei confronti delle informazioni provenienti da fonti istituzionali. Le parole d’ordine diventano scendere sul campo, interagire, contro-informare, etc. Se riflettiamo un attimo sul momento attuale dell’informazione, non sembra poi essere cambiato molto da allora e, ancora oggi, l’obiettivo dovrebbe essere non solo informare, ma bensì formare il lettore. Prendendo spunto dalla vastissima copertura mediatica del conflitto ucraino, che cosa pensi al riguardo?
Quando penso ad un lettore/pubblico spero che dall’enorme flusso di informazioni cui ha accesso possa trovare la sua strada per essere un cittadino informato al meglio e consapevole. E quindi scegliendo chi seguire – come singoli giornalisti, come Podcast, Newsletter, reportage. Che selezioni ciò che gli serve davvero, non ciò che gli viene proposto più spesso.

In questi ultimi anni è indubbio che le “nostre società” stiano avvertendo sempre di più una sorta di apprensione nei confronti del futuro. Mai come adesso infatti è il presente che domina il modo con cui si veicolano le informazioni e la stessa fruizione è tutta improntata all’adesso, al nowness, la proprietà che sembra catalizzare tutte le informazioni di accadere ora o di relazionarsi con l’adesso. Qual’è il ruolo della comunicazione e dei mass media in questa tendenza ed a cosa pensi può portare il nostro focalizzarci sempre più sull’ultima breaking news vivendo metaforicamente in uno scrolling pressoché ininterrotto?
L’adesso è secondo me uno spartiacque nel modo di fare informazione – io stessa lavoro nel canale all news della Rai, Rai News 24, che in questo trae la sua ragione di esistere ed è una parte fondamentale per il nostro lavoro sapere – e dire – cosa sta succedendo adesso in un determinato posto del mondo.
Il passo successivo è dare a quel frammento di notizia un contesto, agganciarlo ad un quadro più grande e più complesso, anche sulla linea del tempo. Qui entrano in campo altri strumenti del giornalismo – la storia, l’economia, la capacità di analisi, l’istinto a trovare una storia in grado di dare un volto alla notizia. Lo stesso vale per i grandi consorzi internazionali di giornalismo: lavorano per mesi e mesi ad un’inchiesta che poi cambia per sempre il nostro modo di vedere (penso ai Panama Papers ma anche al lavoro fatto sul conflitto in Ucraina, sulle cleptocrazie…) – anche loro partono, o arrivano, dall’adesso di cui parlavamo prima. Penso anche che, come giornalisti, sia molto importante restare – con il racconto, con lo studio – quando alcune breaking news smettono di essere la prima notizia del Telegiornale, soprattutto per quei Paesi che non hanno sufficiente copertura mediatica, penso a quelli del continente africano che seguo da anni.
Sempre in relazione al concetto di tempo di fruizione delle informazioni, credo che molto spesso si sottovaluti il ruolo di documentazione storica del materiale che viene realizzato da chi, come te, si trova sul fronte caldo del conflitto. Si tratta infatti di una sorta di archivio del conflitto che acquisterà ancora più rilevanza nei mesi e anni futuri, ogni qualvolta insomma ci sarà necessità di ricostruire quanto accaduto. Potresti indicarci alcuni esempi di questo utilizzo documentale e le ulteriori potenzialità del tuo lavoro da questo punto di vista?
Negli anni ho letto con grande interesse cronache in presa diretta (con i mezzi dell’epoca) di conflitti del passato e soprattutto guardato nelle teche Rai reportage di decenni fa. E lo stesso vale per le raccolte di memorie orali – post coloniali, di rifugiati, di villaggi interi che hanno cambiato identità, di guerre dimenticate… Spero che alcuni colleghi che hanno fatto un lavoro splendido e quotidiano su questo conflitto lo possano conservare per noi e per il futuro perché sono stati veri storici dell’istante.
Uno dei termini che maggiormente sono divenuti centrali in queste settimane di conflitto, in particolare modo in Italia, è senz’altro quella di Resistenza. Facendo riferimento al tuo specifico punto di osservazione del conflitto e alla luce delle tue differenti esperienze sul campo, come pensi si possa definire questa parola, nata per unire e oggi elemento così divisivo?
Resistenza per me, per quello che ho visto in Ucraina (che quindi è un’esperienza limitata alle persone e ai luoghi che ho conosciuto). È una lotta disperata per esistere quando una forza esterna – un esercito, ma anche una macchina informativa – vogliono sottrarti questo diritto. Ed è un sentimento profondo e fondativo che ho visto in territori meno raccontati, lì con una tenacia alimentata dalla consapevolezza di essere considerati marginali, poco raccontati dai media – nella Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, intorno a Goma la società civile sta lottando ogni giorno per rovesciare un sistema politico intriso di corruzione ed economia il cui profitto nasce dal conflitto. Ho visto ad esempio un collettivo di poeti slammeur organizzare e portare a termine rivolte per l’acqua, insegnare nelle scuole la democrazia, denunciare la corruzione rischiando la vita, trasformare le ferite storiche in versi per costruirsi il futuro. E lo stesso in Sudafrica, nelle township dove ancora si lotta per smantellare l’eredità dell’Apartheid, la resistenza è conquistarsi il diritto ad esistere davanti ad un potere che strutturalmente ti esclude, ignora, terrorizza.
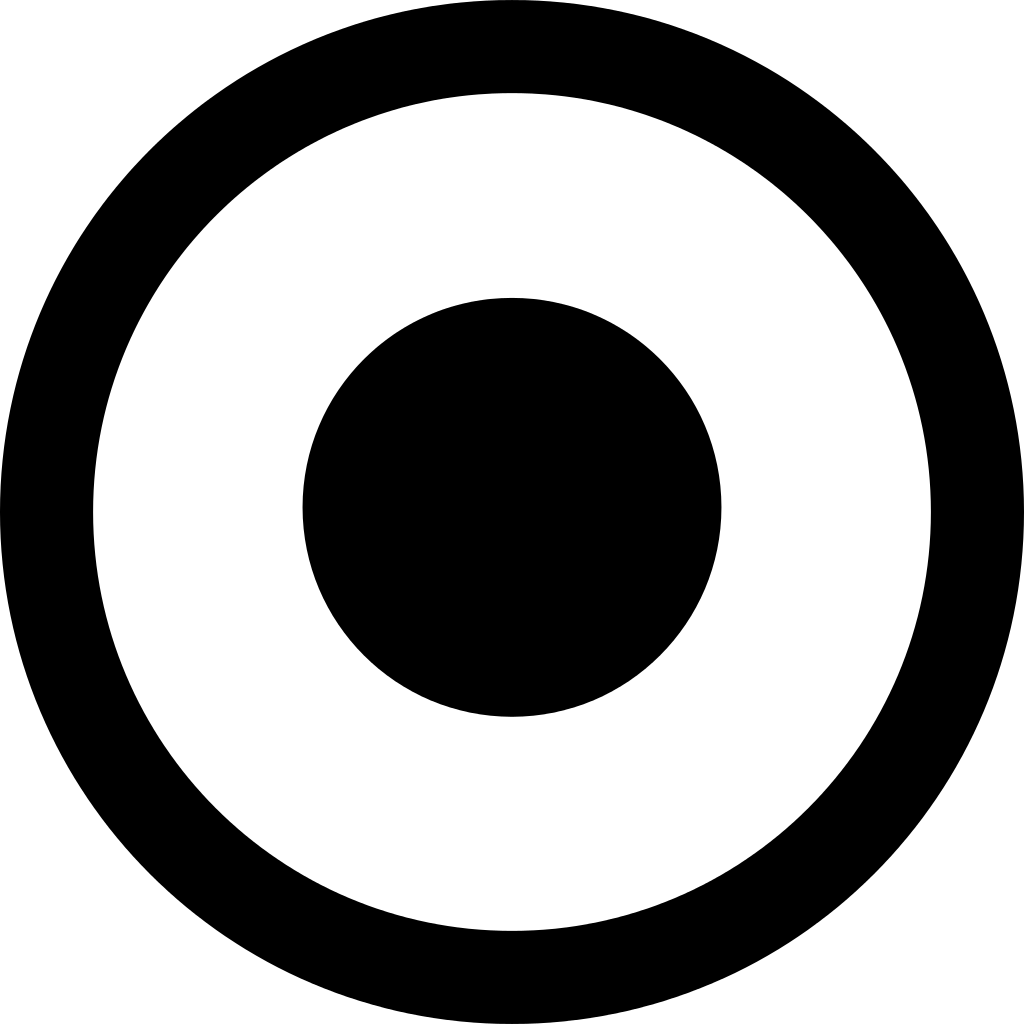 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP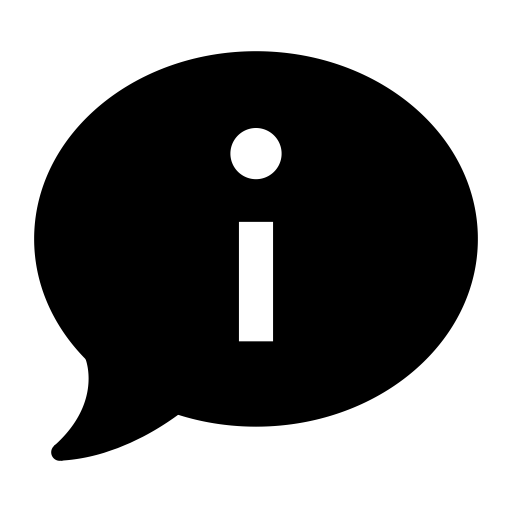 ABOUT
ABOUT 