Continua il nostro viaggio nel mondo della comunicazione in questi tempi di guerra, un viaggio che ci porta a conoscere chi ha deciso di fare del proprio lavoro di giornalista anche quello di testimone diretto dei fatti e oggi ne parliamo con Giammarco Sicuro.
Nato a Montevarchi, in provincia di Arezzo, il 25 gennaio 1983, Giammarco Sicuro lavora in Rai dal 2008 e oggi è uno degli inviati della redazione Esteri del Tg2.
Nella sua carriera ha seguito alcuni degli avvenimenti più significativi degli ultimi anni, come il naufragio della Costa Concordia, il terremoto di Amatrice, gli attentati dell’ISIS in Europa e le proteste dei Gilet Gialli a Parigi.
Da oramai diverse settimane si trova in Ucraina dove testimonia i fatti relativi al conflitto.

Giammarco Sicuro in Ucraina. Foto @Giammarco Sicuro
Ciao Giammarco,
Per prima cosa, ti ringrazio davvero molto per la tua disponibilità a rispondere alle mie domande.
La prima domanda che vorrei farti riguarda i giorni precedenti allo scoppio della guerra. Puoi dirci come si è evoluta la tua situazione, quali sono stati i tuoi spostamenti dal 24 febbraio 2022 fino ad oggi e soprattutto cosa è cambiato per te dal giorno prima dell’invasione fino ad oggi?
Prima di tutto grazie per questa opportunità di parlare di questo terribile conflitto in corso e dell’importanza di un giornalismo sul campo e vicino alla sofferenza delle persone. Per quanto riguarda la domanda, è evidente che questa guerra non sia nata in un giorno e già prima dell’inizio del conflitto, avevamo il sentore che qualcosa di grosso sarebbe accaduto, anche se non su questa drammatica scala. Per questo, mi stavo organizzando per andare in Russia e raccontare quel che stava accadendo da quel lato del fronte.
Il 24 febbraio sono partito con il primo volo per Mosca proprio per il fatto che avevo pronti tutti i documenti necessari alla partenza, come il visto giornalistico ad esempio. Così, poche ore dopo l’inizio del conflitto, mi trovavo già nella capitale russa pronto a raccontare questa orrenda guerra.
Ho trascorso a Mosca una decina di giorni, raccontando la repressione e la propaganda in quel Paese e poi sono stato costretto a lasciare la Russia per evitare rischi e un possibile arresto dovuto alle leggi sempre più restrittive per la libertà di stampa.
Dopo quel periodo, ho trascorso circa un mese in Ucraina, coprendo il lato sud del conflitto, tra le città di Odessa e Mykolaiv, dove attualmente si combatte.
Difficile dire cosa è cambiato per me, credo servirà tempo per assimilare tutto ciò che ho visto e potuto raccontare di questo orribile conflitto.

Giammarco Sicuro in Ucraina. Foto @Giammarco Sicuro
Puoi descriverci come hai vissuto gli ultimi giorni da un punto di vista pratico e logistico? In base a quali elementi scegli i luoghi in cui andare, come trovi il modo di spostarti, quali sono i tuoi strumenti di lavoro e cosa porti con te oltre a quelli?
Raccontare una guerra è complicato per varie ragioni. La prima è ovviamente la sicurezza di noi inviati che, come sapete, non è affatto garantita. Penso ai tanti colleghi che hanno perso la vita dall’inizio dell’invasione, un estremo sacrificio che dovremo ricordare per sempre.
Abbassare al massimo possibile la soglia di rischio è il primo obiettivo quando ti trovi a lavorare in certi scenari. Noi lo abbiamo fatto, avvalendoci della collaborazione di persone del posto, capaci e soprattutto ben preparate ad affrontare situazioni di questo tipo. Si tratta dei cosiddetti “fixer” locali (ne abbiamo parlato QUA), ossia professionisti che hanno i contatti giusti e la conoscenza del territorio e che soprattutto sanno dove è il caso di andare e dove invece è meglio fermarsi.
Oltre a questo, servono protezioni personali come i giubbotti antiproiettile e gli elmetti e una buona dose di buon senso e lucidità.
Gli strumenti di lavoro sono in modalità “light”. Ci si collega per dirette in streaming, dal cellulare e si registrano le immagini con piccole camere (Reflex e action cam) per poi montare tutto successivamente sul proprio computer portatile.
Oltre a quello si portano acqua e barrette energetiche (difficile trovare bar e ristoranti aperti, ovviamente) oltre a un telefono satellitare per comunicazioni di emergenza in zona dove non c’è rete.
Il ruolo dell’inviato nelle zone di guerra immagino preveda una forte capacità di estraniarsi dal contesto, essere cioè in grado di distaccarsi dai fatti di cui si è spettatori per poterli riportare nella forma più oggettiva e neutra possibile. Come riesci tu a farti testimone oculare separando ciò che inevitabilmente registra la tua mente e, in certi casi più estremi, il tuo stomaco senza perdere il controllo o senza lasciare che le sensazioni e i sentimenti prevalgono sul dovere di cronaca?
Una domanda giusta e che entra nel profondo del nostro mestiere, così complicato anche se affascinante e gratificante. Quel che accade in guerra non è poi così diverso da altri grandi fatti di cronaca che negli anni abbiamo potuto seguire e raccontare. Un terremoto, un attentato terroristico, un omicidio di mafia: sempre ci troviamo vicini a grandi tragedie ed è normale che quel dolore ti arrivi direttamente al cuore. Credo sia una questione di abitudine e anche di allenamento: la capacità come giustamente dicevi di alienarsi e concentrarsi sul lavoro e sulla “missione” giornalistica. Prima di tutto siamo lì per raccontare e trasmettere quelle emozioni e la concentrazione e la professionalità a volte ti salvano e ti distraggono dal traposto emotivo. La botta grossa arriva quando torni a casa, tutto si ferma, arriva il silenzio e in quei momenti a volte è dura.

Foto @Giammarco Sicuro
In ogni guerra si è sempre assistito ad ogni tipo di distorsione della realtà, tirata come un elastico da ogni parte come un’ulteriore arma da mettere in campo da parte delle fazioni in conflitto. Allo stesso tempo però, mai come adesso, chi vuole è in grado di vedere tutto, proprio tutto. Questa tensione fra la profusione di immagini e le narrazioni alternative che ci vengono proposte ingenera in chi guarda un forte senso di ansia e di perdita del senso di realtà. Quale pensi sia l’approccio migliore di chi vede tutto questo e non riesce a farsi un’idea di cosa davvero stia succedendo?
Io credo che sia fondamentale, ancora più oggi rispetto al passato, con tutta questa proliferazione di mezzi di comunicazione nuovi come Social Media, affidarsi ai professionisti cioè a coloro che per mestiere sanno filtrare le notizie, trovare i giusti canali, incrociare le fonti e quindi dare un’informazione più vicina alla realtà possibile perché come sappiamo durante una guerra la propaganda si mette in moto su entrambi i lati e abbiamo continue conferme su questo, e quindi è sempre più necessario il lavoro di chi sul posto, giornalisti e inviati professionisti, riescono a realizzare una sintesi da questa massa infinita di video e informazione a cui siamo sottoposti.
Il mio consiglio è quello di affidarsi ai professionisti, a dei profili anche Social perché anche nei Social Media si possono trovare degli interlocutori capaci di aiutare in questo senso, oppure sulle testate riconosciute e affidabili come i grandi network internazionali come il New York Times che sta facendo un lavoro eccezionale in questa guerra, o la stessa CNN. Affidarsi a fonti autorevoli, affidarsi ai professionisti e cercare di farsi un’idea di quello che sta accadendo attraverso i loro occhi e di chi effettivamente paga per persone che stiano sul campo e raccolgano informazioni di prima mano senza affidarsi a notizie di terza o quarta mano trovabili facilmente su Internet e quindi, proprio per questo, molto influenzate dalla propaganda.
Una domanda che mi faccio spesso e che ho sottoposto anche ad altri tuoi colleghi è quella relativa a ciò che io chiamo “decompressione emozionale”, quel periodo di tempo, più o meno lungo, che credo sia necessario a chi come te vive un lungo periodo di tempo in situazioni particolarmente crude e violente, per riuscire a ritornare a vivere una normale quotidianità una volta terminato il conflitto o comunque finito il viaggio. Come gestisci tu questo periodo di decompressione?
Ogni volta che si rientra da un contesto drammatico di questo tipo c’è sempre un periodo di difficoltà ed è normale perché arrivi da un momento di grande pressione lavorativa, ma anche di stimoli e di emozioni, e poi ti ritrovi di colpo a rientrare nella tua vita di tutti giorni e questo può comportare ovviamente stati di ansia, di depressione, nei casi più gravi di stress post traumatico.
Negli anni io mi sono allenato molto nell’affrontare il ritorno da queste situazioni perché ne ho vissute tante e quindi con l’allenamento e con il trovarmici sempre più spesso diciamo che mi sono temprato, credo e spero, a superare questi momenti di oggettiva difficoltà. Uno dei modi migliori per farlo è tornare dai propri affetti e quindi dalle persone più care, stare vicino a loro e farsi dare un supporto. Immergersi nei propri affetti secondo me è il modo migliore per superare il trauma. È ovvio che comunque queste esperienze qualche strascico te lo lasciano sempre. Io per esempio per qualche giorno, ogni volta che anche qui a Roma sentivo dei rumori forti, avvertivo questo stato di allerta che mi riportava ai giorni in cui sentivo i bombardamenti. Il cervello si era abituato a certi stimoli.
Poi però passa tutto e credo, come detto, che il segreto sia immergersi negli affetti e nelle cose piccole ma importanti della vita.
Il filosofo Cartesio era solito sostenere che: «Quale cosa può essere considerata vera? Forse solo questa: che nulla è certo». Per chi come te lavora con la verità di cui è testimone, quale pensi sia una buona definizione di verità?
Questa definizione di Cartesio è assolutamente vera perché alle scuole di giornalismo ti insegnano che il giornalista deve essere obiettivo e, a mio avviso, questa è una grande falsità o meglio, un grande mito da inseguire. Credo che sia giusto tendere all’obiettività e quindi alla ricerca della verità perché nessuno di noi ha in pugno la propria verità e penso sia impossibile che un giornalista che ha i propri valori, la propria storia, la propria cultura, riesca ad essere totalmente obiettivo, soprattutto in una guerra di aggressione dove in qualche modo uno si sente anche un po’ partecipe.
Secondo me il modo migliore e più onesto intellettualmente per affrontare il lavoro è seguire proprio la massima di Cartesio, farsi tante domande, talmente tante domande da mettere continuamente in dubbio le proprie convinzioni. In questo modo magari, non arrivando in un luogo con un’idea preconcetta o un pregiudizio che ti porti da casa, sei in grado anche di vedere le cose da altre prospettive, prospettive alternative, magari anche a mettere in gioco le tue sicurezze e uscire dalla confort zone. Questo è utile per arrivare ad una sintesi più vicina alla verità delle cose possibili. Io quando vado in un posto mi metto molto in gioco e mi faccio tantissime domande e spero così di arrivare ad una visione che magari è più vicina alla realtà delle cose.

Foto @Giammarco Sicuro
Potresti descrivere quali sono le differenze fra un inviato di una testata giornalistica a cui fare riferimento e affidamento e un inviato freelance che si muove in totale autonomia ma comunque senza nessun tipo di supporto esterno?
Questa è una bella domanda ed è una domanda da attento osservatore perché si tratta di uno dei grandi temi che viviamo in quest’epoca, quello cioè del rapporto fra il giornalismo freelance e quello più ingessato ma più protetto del giornalista indipendente, di un grande testata. Io ho la fortuna di lavorare per la RAI e quindi nella seconda delle due categorie.
Ci sono pro e contro da entrambi i lati, ci sono delle situazioni che avvantaggiano il primo e altre il secondo. Direi che è sempre più necessario trovare una sintesi tre le due figure perché in alcune situazioni per esempio, il freelance e questo – lo vediamo bene in Ucraina – rischia di trovarsi senza le protezioni necessarie semplicemente perché magari non ha la disponibilità economica per procurarsi un’assicurazione sulla vita o dei dispositivi di sicurezza che possono essere anche molto costosi.
Ho visto purtroppo alcuni colleghi avventurarsi forse un po’ troppo in questo senso e lo capisco perché si tratta di una “grande occasione” e allora c’è questa necessità da parte di chi non ha un’entrata fissa, di spingersi molto in là. Il giornalismo dipendente ha invece questa garanzia di potersi muovere protetto con tutti i dispositivi di sicurezza del caso. Dall’altro lato, lo svantaggio per il dipendente è quello di avere meno flessibilità rispetto al freelance, deve stare ovviamente più sottoposto a delle logiche aziendali, le turnazioni per esempio; non può andare dove vuole perché ci sono delle indicazioni redazionali in tal senso e questo lo pone in una situazione più complicata dal punto di vista giornalistico in senso stretto perché il freelance è libero di andare domani nel posto più caldo o dove la notizia è in corso, quando invece il dipendente è bloccato da questioni di sicurezza imposte dalla redazione, oppure semplicemente perché le esigenze di redazione sono diverse e tu devi coprire un determinato posto e non puoi muoverti in autonomia in un altro. Ci sono pro e contro in ogni caso.
Storicamente il complesso sistema dell’informazione ha sempre convissuto con una divisione più o meno netta fra comunicazione mainstream e comunicazione indipendente. Innanzi tutto ti chiedo se questa che è una semplificazione può comunque avere ancora un qualche senso in profondità e, se sì, qual’é?
È una domanda complicata perché questa visione è stata molto strumentalizzata negli ultimi anni anche da alcuni partiti politici nell’accusare l’informazione mainstream di avere delle caratteristiche che i realtà non ha. Io lavoro per un media mainstream, forse il più mainstream che abbiamo in Italia cioè la RAI però non mi sento di aver mai subito alcun condizionamento nel riportare alcune notizie piuttosto che altre. È ovvio che la RAI ha un’influenza politica molto forte e alcuni programmi o canali sentono più l’influenza di un potere centrale governativo perché l’azionista di maggioranza della RAI dopotutto sappiamo essere il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) quindi è innegabile che ci sia un a pressione e una partecipazione di poteri forti, ma per quanto riguarda il mio lavoro di inviato non mi sono mai sentito in nessun modo condizionato nell’esprimere o meno una mia visione e quindi dal mio punto di vista e dal lavoro che svolgo ogni giorno non ho mai avuto la sensazione di essere parte di un’informazione mainstream e quindi meno indipendente rispetto ad altri media più piccoli o più flessibili. Questo quindi credo sia un buon segno.
Certo che poi, a livello macro, ci sia ovviamente questa influenza, assolutamente si. L’editoria libera che citi tu, nata appunto negli anni Sessanta, in Italia non ha avuto uno sviluppo paragonabile ad altri paesi. In Italia, di editori puri non ne abbiamo avuti poi molti e quindi l’informazione resta molto ancorata al potere politico centrale, ad una visione del mondo abbastanza comune e rigida ed ecco che allora cerchi qualcosa di più indipendente in piccole realtà. Questo però non significa che anche in alcuni media mainstream non sia possibile trovare un’informazione valida e a suo modo indipendente che è quella per esempio di noi inviati, e siamo tanti, che andiamo nei posti e riusciamo a fare un’informazione libera e basata su quella che è la nostra coscienza. Non vedo grosse pressioni. Possiamo dire che è vero che ci sono due anime, ma come in tutte le dinamiche complesse, non dividerei con nettezza fra bianco o nero, ma partirei dalla consapevolezza che tutto oggi è molto ibrido, più ancora di quanto si pensi. Esiste infatti ottima informazione indipendente nei media mainstream come ne esiste di pessima nelle piccole realtà che spesso si dimostrano oggi assai influenzate politicamente.
Per quello, tornando alla prima domanda della nostra chiacchierata, credo sia necessario affidarci a professionisti e fare riferimento a loro.

Foto @Giammarco Sicuro
Dallo specifico punto di osservazione in cui ti trovi, quali pensi siano oggi i maggiori limiti e le maggiori potenzialità che esistono nel modo di informare l’opinione pubblica?
Io credo che l’avvento dei Social Media sia una grandissima opportunità che ancora non abbiamo saputo cogliere a pieno per diffondere un’informazione ben fatta. In Italia siamo molto indietro da questo punto di vista. Abbiamo lasciato campo nel mondo dei Social Media ad un tipo di comunicazione – non di informazione – molto frivola o fine a se stessa, in taluni casi addirittura controproducente. Abbiamo dato molto spazio a professionisti della diffusione di Fake News che non sono professionisti dell’informazione perché hanno un obiettivo politico e propagandistico. Credo inoltre che ci siano dei margini notevoli in cui potremmo realizzare informazione di qualità anche sui Social Media anche perché ritengo che il futuro sia innegabilmente quello al di là della televisione che credo sia destinata sempre più a forme ibride o forse addirittura a scomparire nel lungo periodo. Credo che in Italia sia necessaria una profonda riflessione sul ruolo dei nuovi media come piattaforma per diffondere informazione sana, competente, professionale e su questo ci troviamo ad un punto di partenza. Dobbiamo investirci di più, crederci di più. È quello il campo su cui investire con soldi, professionalità e interesse perché è li che stanno le giovani generazioni che non guardano assolutamente i Telegiornali generalisti.
Un ultima domanda che mi è venuta mentre parlavamo. Vedendo il gran numero di inviati, freelance e non, dal conflitto in Ucraina, credo si possa cominciare ad effettuare anche alcune analisi sugli stili comunicativi con cui ognuno realizza il proprio lavoro. Un aspetto che mi ha colpito dei tuoi contenuti inviati dall’Ucraina, soprattutto sui Social Media, e non so se si tratta di una decisione preventiva o se è emersa in modo naturale, è quella di intervallare momenti drammatici e violenti con altri, e penso per esempio agli approfondimenti sulla cucina, sul vino ed altro, di simpatia – sempre che si possa utilizzare questo termine durante un conflitto. È uno stile che ti appartiene o è un modo per rendere più fruibile il materiale che produci?
Non ho mai pensato di “addolcire la pillola” o edulcorare i contenuti. Diciamo che invece è proprio il mio modo di approcciare la vita, in tutti i suoi aspetti. Non ho iniziato con l’Ucraina, lo faccio da sempre, in tutti i contesti in cui di volta in volta mi sono trovato a lavorare. Penso sia anche un modo per esorcizzare e limitare quello che è l’impatto duro di certe realtà. Dopotutto l’essere umano ha sempre bisogno di dare uno spazio alla leggerezza e alla curiosità e questo lo dimostra il grande interesse in questo aspetto che va oltre al racconto drammatico che, per forza di cose, contraddistingue il mio lavoro in questi contesti. Serve anche altro perché la vita, per fortuna, è fatta anche di altro, di aspetti positivi o incoraggianti o speranzosi. È un approccio che ho sempre avuto e che utilizzo anche nella scrittura come, per esempio nel mio libro L’anno dell’alpaca che è su questo stile anche se li parlavo del COVID.
C’è e ci deve essere sempre un modo per trovare lo spazio per un sorriso o per alleggerire la situazione drammatica.

Foto @Giammarco Sicuro

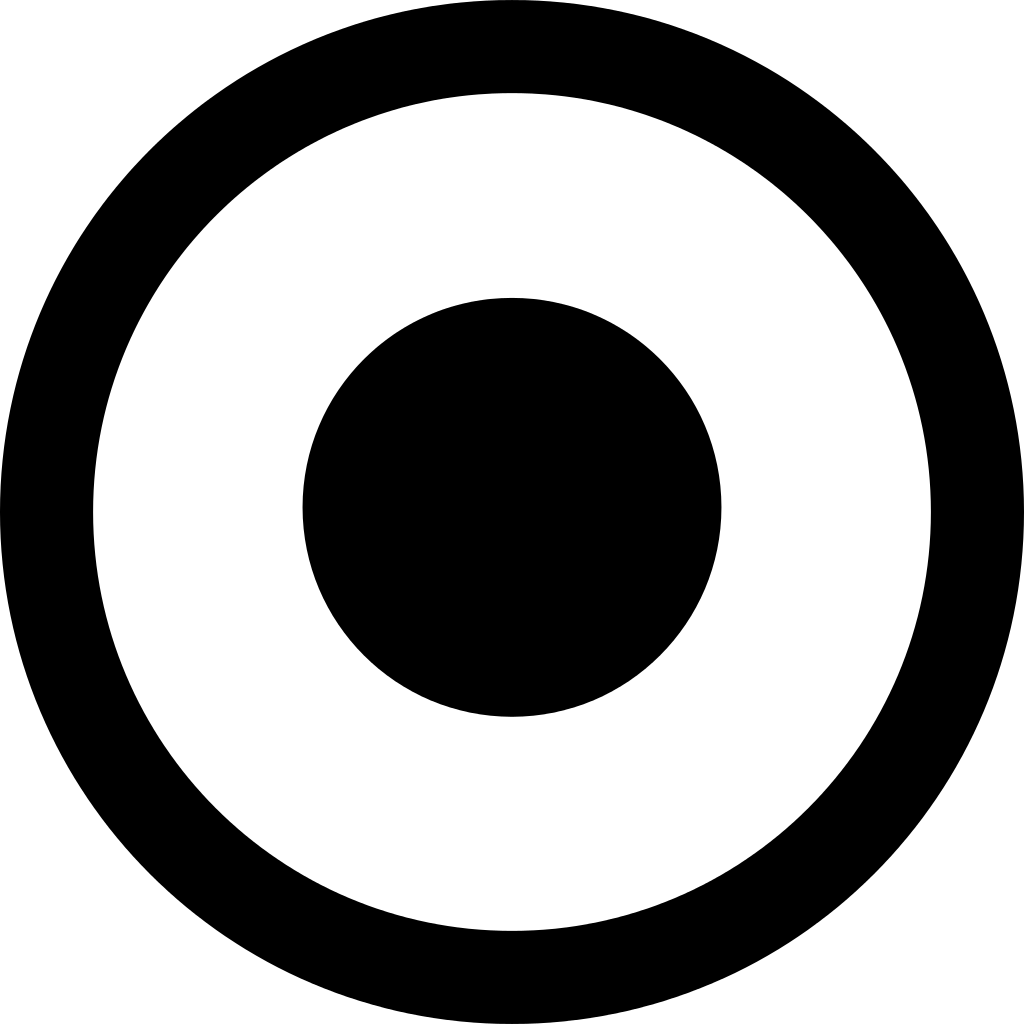 CENTRO STUDI EDF
CENTRO STUDI EDF  SHOP
SHOP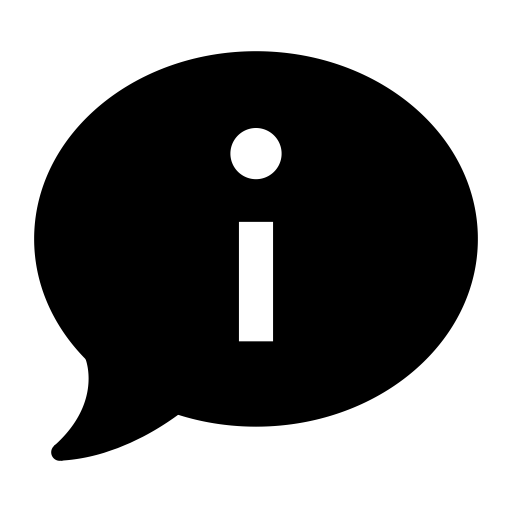 ABOUT
ABOUT 